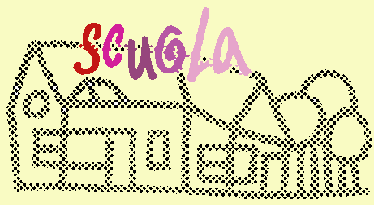 |
Direzione didattica di Pavone Canavese |
La Qualità dell'integrazione scolastica
Questo libro contiene vari tipi di contributi articolati in aree specifiche:
1. saggi e ricerche originali prodotti in occasione del Convegno internazionale "La Qualità dell'integrazione scolastica" (Riva del Garda, novembre 1997) o successivamente;
2. materiali di lavoro su temi di attualità;
3. resoconti di nuove prassi di integrazione o intervento didattico-educativo, tra quelli che hanno vinto le ultime due edizioni del premio "Esperienze di integrazione", indetto dalla rivista "Difficoltà di apprendimento";
4. allo scopo poi di sostenere con forza sia il ruolo attivo che dovranno assumere i compagni di classe, sia l’impatto positivo che ha l'integrazione su tutto il gruppo classe, abbiamo raccolto alcuni contributi importanti, italiani e stranieri, nella sezione dal titolo "La risorsa compagni".
Il volume rappresenta di per sé un'occasione di integrazione.
È il frutto delle riflessioni di autorevoli esperti italiani e internazionali e del Lavoro di diverse istituzioni che, sul territorio nazionale, portano avanti da decenni un qualificato impegno a sostegno della piena integrazione scolastica, lavorativa e sociale di tutte Le persone in situazione di handicap. Sia permesso citare, fra i tanti contributi, quelli offerti dal Centro studi Erickson di Trento (unitamente alla rivista "Difficoltà di apprendimento") e dal Comitato per l'integrazione scolastica degli handicappati (insieme alla rivista "Handicap & Scuola"), che - nella seconda metà degli anni '90 - ha promosso numerose iniziative per richiamare l'attenzione sul tema "Qualità", offrendo anche alcune indicazioni su come valutarla e come migliorarla. È significativo, inoltre, che questo libro sia stato curato dai direttori delle due riviste. Circa la struttura del volume, le quattro tipologie di contributi prima citate sono state combinate in sette grandi sezioni tematiche.
I fondamenti e il quadro
In queste prime due aree sono incluse le riflessioni di taglio culturale e pedagogico di Canevaro, quelle più operative di Stainback e di Vianello, fino a quelle politico-metodologiche di Piazza.
Accanto a questi saggi abbiamo riportato integralmente la relazione finale della VII Commissione della Camera dei Deputati, che rappresenta il documento valutativo ufficiale più recente e articolato, frutto di mesi di audizioni e visite a scuole e Enti. Questa relazione ha fatto discutere molto (anche se non abbastanza, essendo ancora poco conosciuta) e ha suscitato autorevoli commenti, come quelli di Rollero e Tortello, qui riportati, accanto a importanti contributi di rilettura giuridica e pedagogica della normativa (Spagnoli e Nocera). Completano la sezione un'analisi a 360 gradi di Neri dell'attività dell'Osservatorio Permanente sull'integrazione del Ministero della Pubblica
Istruzione e delle tematiche più scottanti della situazione attuale dell'integrazione nel nostro Paese, e la panoramica di Pavone sulle prospettive internazionali dell'integrazione.
Le strategie di base
I contributi qui raccolti toccano i temi operativamente più rilevanti, gli ingredienti base per un'integrazione di ottima qualità: il collegamento e la connessione stretta e significativa tra programmazione individualizzata e obiettivi perseguiti dalla generalità degli altri alunni (Celi), e il lavoro sulla dimensione dei rapporti inclusivi con i compagni di classe, sia negli aspetti di reticolazione informale delle relazioni di aiuto sia in quelli più formali dell'apprendimento cooperativo e del tutoring (Ianes), con particolare attenzione e approfondimento sul tema dell'apprendimento cooperativo in piccolo gruppo, uno dei metodi più efficaci per organizzare una classe accogliente e funzionale all'integrazione (Chiari).
Un contributo di ricerca di Cornoldi, sullo sviluppo di competenze autonome di lavoro scolastico attraverso un intervento metacognitivo, dimostra che il far scuola puntando all'autoconsapevolezza e all'autoregolazione dell' alunno pone le basi necessarie per un'individualizzazione "autogestita" dallo studente, che può sviluppare un proprio peculiare rapporto con le varie esperienze di apprendimento.
E così, in una classe in cui sono presenti vari approcci differenziati, le differenze individuali (anche le disabilità) non rappresentano l’eccezione, ma la regola.
La considerazione delle differenze individuali viene esplorata anche nello studio di De Beni e Zamperlin, con attenzione particolare alle differenze negli stili cognitivi, che rappresentano una chiave di lettura fondamentale nelle varie situazioni di disturbi dell'apprendimento e di svantaggio socio-culturale.
Se negli ultimi anni si è sempre più spesso ripetuto che l'integrazione degli alunni in situazione di handicap non può essere separata dal (o meglio sarà realizzata attraverso il) miglioramento della qualità della scuola per ogni alunno, gli studi di Cornoldi e di De Beni e Zamperlin portano un importante contributo allo sviluppo di una sempre maggiore attenzione alla conoscenza delle differenze individuali e alle prassi d'individualizzazione.
Chiude la sezione l'esperienza della Scuola Elementare di Calvisano (BS) (Borghetti et al.), in cui si mette in pratica l'integrazione dell'alunno in situazione di handicap anche attraverso un percorso di educazione interculturale, in cui viene ribadito (e dimostrato) che ogni diversità è una ricchezza da valorizzare.
La risorsa compagni
Questa sezione riprende e sviluppa in profondità le indicazioni fornite su questo tema da Ianes e Chiari nella sezione "Le strategie base". Apre la serie di contributi l'ampio saggio di Rollero sulle molteplici dimensioni "sociali e interpersonali" dell'integrazione, che è essenzialmente un'avventura di scambio e di relazioni, di cui beneficiano gli alunni in situazione di handicap e quelli cosiddetti "normali", come dimostrato ampiamente dalla ricerca di Peck, Donaldson e Pezzoli. Ma come facilitare lo sviluppo di relazioni interpersonali costruttive, reciproche, collaborative, accoglienti, ecc.?
Abbiamo riportato tre diversi studi per proporre un buon numero di strategie pratiche: quello di Salisbury et al. (riferito a una serie di attività a livello di scuola elementare), quello di Janney e Snell (centrato soprattutto sulle strategie di facilitazione utilizzabili direttamente dagli insegnanti) e quello di Moretti et al., ambientato nella scuola materna.
Gli strumenti
Gli insegnanti impegnati nell'integrazione si trovano quotidianamente a confronto con tante piccole grandi questioni estremamente concrete, che proprio per questo costituiscono elementi fondamentali per la costruzione di una reale Qualità dell'integrazione. I contributi di questa sezione riguardano molti di questi aspetti concreti: come semplificare e adattare i libri di testo (Scataglini e Giusti ni), come facilitare la lettura e la comprensione di un testo scritto (Pazzaglia e Zamperlin; Ferraboschi e Meini), come condurre un progetto di ricerca su temi di storia (Moldi, Zordan e Ghiotto), come insegnare le abilità metacognitive matematiche (Lucangeli), come intervenire sui disturbi dell'apprendimento (Malaguti), come utilizzare le potenzialità dell'informatica (Ricci) e in particolare della multimedialità (Gerosa) e - ultimo, ma non certo in ordine di importanza - come integrare in modo significativo i disabili gravissimi (Zucchi).
Le risorse della scuola e degli insegnanti
L'integrazione si attualizza in una realtà organizzata, costituita prevalentemente da persone, persone non abituate a collaborare realmente e a valutare la qualità di processo e di prodotto del loro operato. Nelle scuole del 2000 diventeranno prassi cruciali nell'autonomia gestionale e formativa la definizione della Carta dei Servizi (Rusconi), la valutazione della Qualità attraverso la customer satisfacrion (Drago), la collaborazione tra gli insegnanti nei vari gruppi di studio e lavoro (Pavone e Tortello) e la definizione collegiale delle prassi di valutazione della Qualità (Bertin e Porchia). La Qualità dell'integrazione risente anche della qualità della vita degli insegnanti e del loro grado di capacità di gestione attiva dello stress e di questo si occupa l'ultimo contributo in questa sezione, quello di Di Pietro e Rampazzo.
Le risorse dell 'extrascuola
Se è vero che la scuola non è un'isola, è altrettanto - e ancor di più - vero che l'integrazione scolastica deve avere radici forti fuori della scuola, e in primo luogo nella famiglia (o meglio nelle famiglie di tutti gli alunni, non solo in quelle degli alunni in situazione di handicap). Il contributo di Milani affronta appunto il tema della partnership scuola-famiglia, nel contesto delle iniziative di "educazione familiare". Di partnership parlano anche Savelli e Biancardi e Stella, nelle loro riflessioni sulla collaborazione tra scuola e operatori dei servizi sanitari. La questione è senz'altro complessa e delicata, ma questi due contributi suggeriscono concretamente alcune strategie praticabili, sia in generale sia nel caso specifico della dislessia. Quanto questa possibile partnership sia diffusa nelle scuole del nostro Paese è un dato ancora misterioso. Certo è che da più parti si levano voci a sostegno della creazione di un Servizio di psicologia scolastica (o psicologia dell'educazione), che riesca a fornire un buon supporto tecnico agli insegnanti (e alla scuola nel suo complesso), svincolandosi da un'appartenenza sanitaria e con un modello di intervento il meno possibile clinico-individualistico. Trombetta propone questa figura, lo psicologo scolastico, che colmerebbe l'assurdo distacco che esiste tra il mondo della scuola e della psicologia e che si porrebbe con maggiore chiarezza professionale e di ruolo rispetto all’ambivalenza dello psicopedagogista e alla scarsa
preparazione psicologica del pedagogista (anche se vuole definirsi "clinico"). Un ottimo esempio di "radicamento" della scuola nel territorio è illustrato nello stimolante contributo di Bernardi e colleghi, che descrive un'esperienza di integrazione attraverso un progetto di riscoperta del quartiere.
In queste sette grandi aree sono raccolti i contributi di questo volume, che - ognuno perla sua parte - ci fanno fare molti passi in avanti nel cammino verso l'integrazione di Qualità; ma molto rimane ancora da fare, e nelle ultime riflessioni cerchiamo di identificare nodi ancora irrisolti, piste di lavoro, priorità e temi da affrontare in questo ingresso nel terzo millennio.
Queste argomentazioni costituiscono, assieme alle proposte e stimoli che raccoglieremo da persone e associazioni (sito http://www.erickson.it- forum aperto Qualità 1999), la base di ricerca e di discussione del prossimo convegno Erickson sulla Qualità dell'integrazione scolastica - Riva del Garda che si terrà nel novembre 1999. La prima edizione del convegno Erickson su questo tema si svolse esattamente un anno fa e coinvolse 1.600 persone provenienti da tutta Italia, per ribadire il valore irrinunciabile dell'integrazione e per affinare la propria strumentazione concreta di lavoro quotidiano. Questo è anche l’obiettivo del presente volume, che getta idealmente un ponte tra i lavori del convegno svoltosi a Riva del Garda nel novembre 1997 e quelli in programma per il novembre 1999.