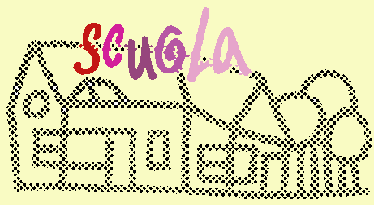 |
Direzione didattica di Pavone Canavese |
(01.03.01)
Strutture speciali per
handicappati gravi
di Mario Tortello
Per gentile concessione dell'autore pubblichiamo in anteprima l'editoriale che compare sul n. 2 della Rivista "Leggi dell'integrazione" pubblicata dalla casa editrice Erickson
Lettere, telefonate e e-mail in arrivo da diverse parti
d'Italia segnalano con preoccupazione alcune ipotesi, avanzate per lo più in ambito
medico-clinico, finalizzate a riproporre strutture diurne di tipo sanitario o
assistenziale per persone disabili considerate in "situazione di gravità",
anche in età d'obbligo di istruzione.
A scanso di equivoci, riproponiamo in questa sede il nostro pensiero, (1) ribadendo la
disponibilità a un ampio confronto che abbia come obiettivo ultimo l'effettiva tutela dei
diritti fondamentali delle persone disabili in "situazione di gravità".
Già il compianto Sergio Neri, coordinatore dell'Osservatorio permanente per
l'integrazione scolastica delle persone in situazione di handicap istituito dal ministro
della Pubblica Istruzione nel giugno 1997, ha messo giustamente in guardia da certe
prospettive: "Un problema molto attuale sta davanti a noi: che non è tanto
importante per la quantità delle persone coinvolte, quanto perché è sintomo di una
situazione di disagio in cui di nuovo stiamo ritornando. È il problema dei cosiddetti
gravissimi. Stanno nascendo dei centri per gravissimi, in età scolare dai 6 ai 14 anni,
nella scuola e anche fuori dalla scuola, all'interno di un circuito gestito dalla sanità
o dai servizi sociali: si ripropone, sostanzialmente, un'idea di persone [...]
riabilitabili, ma [ritenute] non educabili, non istruibili o se volete educabili
separatamente dall'istruibile, che facilmente diventa un addestrabile all'interno di una
situazione di contenimento di effetti più gravi. Bisogna ripercorre un cammino culturale,
già avviato nel nostro Paese e in altri Paesi civili: passare dalla considerazione di una
situazione
ritenuta di irrecuperabilità a una ritenuta di recuperabilità, poi di persone educabili,
finalmente di persone istruibili". (2)
E Dario Ianes avverte: bisogna "accettare la sfida dell'integrazione totale degli
alunni in situazione grave o gravissima di handicap, per i quali occorre trovare forme
ancora più avanzate di integrazione, evitando il rischio di un ritorno a interventi
separati e segreganti". (3)
Si tratta di un orientamento assunto anche dal ministero della Pubblica Istruzione in sede
di audizione alla Commissione VII della Camera sullo stato di attuazione e sulle
prospettive di intervento in materia di integrazione scolastica. Proprio in merito agli
allievi disabili in situazione di gravità, viale Trastevere ritiene necessario,
nell'ordine:
1. "porre esplicita attenzione ai cosiddetti gravissimi";
2. "facilitare una effettiva riduzione dell'handicap";
3. "evitare forme surrettizie di scuola speciale".
La scelta dell'espressione "riduzione dell'handicap", al posto di quella che
richiama la "riduzione del deficit", risponde a una concezione scientifica di
grande valore e di notevoli conseguenze: (4) rispetto alle difficoltà di
ridurre il deficit, molte sono le possibilità di ridurre, e anche di annullare,
l'handicap. La conseguenza è ovvia e richiama l'importanza fondamentale di un impegno
educativo che privilegi, con le persone in situazione di handicap, la comunicazione, le
relazioni, la socializzazione e l'integrazione (legge n. 104/1992, art. 12, comma 3).
Può essere realistica la lettura che individua almeno tre orientamenti in atto rispetto
all'educazione e all'istruzione di persone in situazione di handicap grave: (5)
a) vi è un modello integrazionista forte, che sostiene la necessità di promuovere
l'integrazione sempre e comunque;
b) vi è un modello integrazionista moderato, che propone l'accoglienza nella scuola
comune, ma in classi cosiddette "attrezzate";
c) vi è un modello integrazionista debole [o nullo, per quanto attiene alla scuola], che
pensa all'integrazione sociale come a un esito più che come un presupposto.
Ma, in Italia, il legislatore ha già fatto una scelta; dal 1971 in poi, tutti i
provvedimenti normativi e amministrativi orientano gli interventi a sostegno
dell'integrazione piena nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado,
escludendo spesso anche esplicitamente soluzioni diverse.
Sia sufficiente citare il momento più alto della lunga stagione normativa:
la sentenza n. 215/1987 della Corte Costituzionale, vera "Magna Charta"
dell'integrazione scolastica in Italia. (6)
Ricorda il giudice costituzionale che "è ormai superata in sede scientifica la
concezione di una radicale irrecuperabilità degli handicappati" e che non è
possibile "assumere come insuperabili gli ostacoli che è invece doveroso tentare di
eliminare, o almeno attenuare, [dando] per dimostrato ciò che va concretamente verificato
e sperimentato". E argomenta: "L'inserimento e l'integrazione nella scuola hanno
fondamentale importanza al fine di favorire il recupero [...]. Insieme alle pratiche di
cura e riabilitazione a al proficuo inserimento nella famiglia, la frequenza scolastica è
dunque un essenziale fattore di recupero e di superamento dell'emarginazione [...]. È
evidente che un'artificiosa interruzione, facendo mancare uno dei fattori favorenti lo
sviluppo della personalità, può comportare rischi di arresto, quando non di
regressione".
Tali principi sono stati recepiti anche dalla legge-quadro sull'handicap n. 104/1992, che
all'art. 12, comma 4, recita: "L'esercizio del diritto all'educazione e
all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre
difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap".
Nel nostro Paese, la direzione di marcia è perciò chiaramente indicata: sono i modelli
integrazionisti cosiddetti "moderati" e "deboli", pur presenti, che
debbono intraprendere la strada dell'integrazione "forte"; non è quest'ultima
che è chiamata a cedere il passo a forme diverse di educazione e di istruzione, proprio
nel momento in cui sul piano internazionale - come annota l'Ocse - si cerca di passare
"da sistemi che gestiscono soprattutto un'offerta separata per gli studenti con
esigenze speciali [...] a sistemi più integrati che cercano di includere tutti gli
studenti nelle stesse scuole". (7)
Mario Tortello
NOTE
(1) Cfr. Tortello M. (1999), Nuovi elementi di Qualità per una scuola inclusiva.
In D. Ianes e M. Tortello (a cura di), Handicap e risorse per l'integrazione, Trento,
Erickson, pp. 327-329.
(2) Neri S. (1998), La scuola delle autonomie: impegni e prospettive dell'Osservatorio
nazionale per l'integrazione scolastica, Handicap&Scuola, vol. 13, n. 79, pp. 3-6.
(3) Ianes D. (1999), Editoriale, Difficoltà di apprendimento, vol. 4, p. 301.
(4) Canevaro A. (1999), Pedagogia speciale. La riduzione dell'handicap, Milano, Bruno
Mondadori.
(5) Ricci C. (1999), L'integrazione della persona in situazione di handicap grave nella
prospettiva della psicologia della salute. In D. Ianes e M. Tortello (a cura di), Handicap
e risorse per l'integrazione, Trento,
Erickson, p. 207.
(6) Cfr. Nocera S. (1987), La Sentenza della Corte Costituzionale sui diritti degli alunni
handicappati, Annali della Pubblica Istruzione, n. 6, pp. 662-663; Rollero P. e
Tortello M. (1997), Una rilettura pedagogica della Sentenza della Corte Costituzionale,
Handicap&Scuola, n. 1, pp. 2-5.
(7) OCSE (1999), Uno sguardo sull'educazione. Gli indicatori internazionali
dell'istruzione, Roma, Armando, p.232.