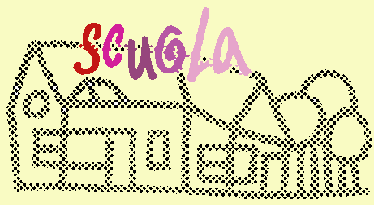 |
PavoneRisorse |
24.01.2015
C’est la
faute à Voltaire: se Voltaire diventa un brand…
di Franco De Anna
Si sa, il tempo della
riflessione, al tempo della sua infinita riproducibilità, è compresso e
compromesso dalla velocità dei media e della loro infinita capacità di
orientare, sollecitare, provocare, la pubblica opinione.
Nell’arco di pochi giorni dalla tragedia di Parigi la discussione pubblica
ha cambiato più volte registro. E non mi riferisco alle opinioni, ovviamente
diverse, a confronto, ma proprio al registro dell’argomentare, ai
riferimenti messi in campo, alle “identificazioni” prontamente rielaborate
come i tanti e diversi (tutti mediaticamente fortunati, anche quando in
opposizione tra loro) “Je suis…”.
L’eredità dell’illuminismo
Siamo partiti con il
richiamo generale “all’illuminismo” come radice propria della cultura
dell’Occidente, base del sistema dei diritti e delle libertà che
costitui-scono (-rebbero) il contributo fondamentale della cultura europea
alla civiltà umana…
Nel nostro mondo di scolastici, l’amico Tiriticco è immediatamente
intervenuto con interessante contributo (mancherebbe…). E commenti
appropriati anche nelle pagine di questo sito.
Notizia recente è che, stimolato intensi e ripetuti richiami, vi è un
significativo incremento delle vendite del “Trattato sulla tolleranza”.
Chissà se gli interessati nuovi lettori sapranno cogliere (qualcuno lo
spiegherà loro?) la consapevolezza che “quel” Voltaire è notevolmente
diverso dal giovane che scrisse il “Trattato di metafisica”, predicatore
entusiasta della libertà dell’uomo. Tra il primo e il secondo vi è la misura
del dramma del terremoto di Lisbona, lo sconcerto del confronto con la
miseria umana, con la morte, con la dimensione del dolore della vita. Con
l’incontrollabilità razionale del destino.
La tolleranza e il suo fondamento si collocano, anche per Voltaire, in
quella dimensione, più che nella astratta affermazione della libertà.
Del resto… l’Illuminismo è davvero il contributo specifico della cultura
europea alla civiltà umana?
La cultura tedesca, “dopo” Goethe e Schiller non produsse forse la tragedia
del nazismo?
E la/le guerre mondiali che hanno segnato il ‘900 hanno forse altri padri e
madri? E non si tratta solo di “deviazioni e parentesi” di dittature.
I civilissimi cittadini di Weimar, città di Goethe, non potevano
materialmente non accorgersi di ciò che accadeva a pochi chilometri da loro,
sulla collina ben visibile di Buchenwald…
Se proprio dobbiamo usare il costrutto del “je suis…” credo che ciò
che segue l’affermazione di identità europea possa e debba essere un elenco
lungo, che articola certezze luminose con miserie e colpe infami, generosità
ed egoismi, eroismi e tradimenti; violenza e diritti, giustizia e massacri.
Della “triade” rivoluzionaria (libertà, uguaglianza, fraternità) cosa
potremmo ragionevolmente raccontare ai nostri figli?
La libertà ha trovato traduzione progressiva nei diritti. In quelli politici
certamente; quelli civili (fondamentale e intangibile quello di proprietà)
via via riconosciuti ma non senza drammi (che dire della Repubblica francese
post rivoluzionaria che confermò la schiavitù nelle sue colonie?); quelli
sociali in crescita potente e significativa nel trentennio successivo alla
seconda guerra mondiale con l’affermazione del welfare… Ma oggi?
L’eguaglianza? Se c’è una fase storica nella quale si moltiplicano le
disuguaglianze è quella che stiamo vivendo. O meglio: dati alla mano le
disuguaglianze tra le nazioni (per esempio tra quelle sviluppate e quelle
in via di sviluppo) si vanno lentamente riducendo; ma si accentuano le
disuguaglianze all’interno delle diverse popolazioni. La guerra alla povertà
sembrerebbe oggi vinta; ma… con la sconfitta dei poveri.
Il terzo termine della triade rivoluzionaria è sempre stato per la verità
quello di più difficile e controversa interpretazione. La fraternità, (o la
fratellanza…) in cosa consista davvero è assai problematico definire…
Probabilmente perché sui tratta di un valore cui è difficile dare semantica
convincente rimanendo sul piano della “ideologia” della laicità, o del puro
esercizio della “ragione”.
Chiedersi (è stato fatto ripetutamente e da pulpiti diversi) come sia
possibile che vengano reclutati terroristi tra giovani apparentemente
cresciuti ed integrati nella “nostra civiltà” urbana è domanda carica di
ipocrisia appena ci si misuri davvero con le poche e necessariamente
superficiali considerazioni precedenti.
Il riferimento all’Islam come causa, in questa chiave, è altrettanto
ipocrita e sostanzialmente isomorfo all’opposto riferimento che fa
dell’Islam la leva strumentale per il reclutamento terrorista agita da altri
soggetti e da altre politiche.
E tale ipocrisia costringe a singolari acrobazie concettuali, come quella
che ricerca “l’Islam moderato”. Si può e si deve ovviamente cercare e
affermare il rispetto reciproco di tutte le religioni; ma è francamente
risibìle chiedere ad un credente di esprimere una “fede moderata”. Lo dice
un ateo come me: si può mai chiedere ad una persona di credere in dio
moderatamente?
E del resto è altrettanto carica di ipocrisia la presa di posizione più
squisitamente politica di Paesi che si propongono come paradigmi di libertà,
ma che agiscono in un panorama caratterizzato da contraddizioni evidenti
nei reciproci rapporti internazionali.
Non sono oggetto della riflessione che qui propongo, ma certamente non si
può non ricordare che Qweit e Qatar finanzino l’autoproclamato califfato
perseguendo interessi ed equilibri complessivi del medio oriente.… che quel
movimento si sia sviluppato sulla base della destabilizzazione del regime
siriano e delle ambiguità ed incertezze del comportamento dei paesi
occidentali… Che il califfato abbia sviluppato una sorta di sistema di
piccola impresa estrattrice di petrolio che viene venduto clandestinamente
sul mercato internazionale con buoni profitti….
E ricordare che in Nigeria il successo e l’espansione di Boko Haram
sarebbero inspiegabili senza debolezze complici dell’esercito nigeriano, la
rapina del paese da parte di una classe politica che, a partire dal
presidente cristiano, ha tradito gli accordi per l’alternarsi di cristiani e
mussulmani alla presidenza (In Nigeria la popolazione è sostanzialmente
suddivisa in termini quasi paritari tra le due religioni..)… e insieme al
miope perseguimento di egoistici interessi nazionali dei pesi europei,
l’inconsistenza di una politica estera dell’Unione, vi è il consistente,
dinamico e non appariscente intervento cinese in tutta l’Africa.
Un cumulo di cause, di riflessioni, di consapevolezze che attendono di
essere approfondite nel dibattito dell’opinione pubblica la cui attenzione
invece viene “deviata” sull’Islam e sui versetti del Corano. E vi è chi si
presta volentieri a tale strumentalizzazione.
C’è naturalmente una aggravante nazionale: siamo un paese di particolare
ignoranza religiosa. Se dovessi citare i versetti “violenti” della Bibbia
gran parte degli interlocutori mi indicherebbero coerentemente e preoccupati
come terrorista.
Nei Paesi della Riforma, almeno, la lettura del libro accompagna la
religiosità, e i fedeli sono stati abituati ad interpretare (e prima di
tutto a leggere e scrivere, a livello popolare, almeno un paio di secoli
prima di noi)… Ma da noi (con insegnamento religioso previsto come
“normale”, fatta salva scelta esplicita delle famiglie) chi legge la Bibbia?
Ma la riflessione che voglio qui proporre pur richiamando la necessità di
quella analisi politica a fronte delle parzialità, opacità, deformazioni
nell’orientamento della “opinione pubblica” , non sta sul piano
dell’analisi politica. Penso piuttosto al rapporto tra tutto ciò e le
domande che tutto ciò pone alla dimensione della formazione.
Diritti, religioni e laicità.
Impegnato in questi
pensieri mi è tornato per le mani un libro di un illustre interprete del
pensiero laico, di scuola mazziniana, interprete di Bobbio, attento anche a
problematiche formative. Mi riferisco a Maurizio Viroli, e il libro in
questione tra i tanti da lui scritti ha un titolo che esprime un programma
“Come se dio ci fosse: religione e libertà nella storia d’Italia”.
Il riferimento che faccio ad esso è in realtà un riflesso specchiato, e
dunque richiede un doppio registro. Il titolo scelto da Viroli richiama un
costrutto fondamentale che spesso viene ascritto a Dietrich Bonhoeffer il
pastore luterano che partecipò alla congiura per uccidere Hitler (fu
giustiziato, fallita la congiura) e che nel dramma della propria coscienza
di cristiano che accettava tormentosamente l’idea dell’omicidio del
tiranno, avrebbe cercato una definizione di diritto e di etica comunque
validi “Come se dio non ci fosse”.
E’ un costrutto spesso ri-utilizzato dal pensiero laico, quando voglia
indicare la necessità di norme giuridiche e di definizioni etiche valide a
prescindere da ogni fede religiosa e dunque proponibili come universali
all’interno di una società tollerante e promuovente i diritti individuali e
collettivi.
Ora io non so se si tratti di un infortunio o se dipenda dal fatto che
Viroli (forse) abbia scritto il libro in inglese con il titolo che suona “As
if God existed…”
Ma quel doppio riferimento usato per illustrare una cultura nazionale
certamente non caratterizzata da alto livello di laicità, ha una origine
lontana . Il costrutto è in realtà di Grozio e risale alla prima metà del
seicento, quando egli (cristiano riformato ma di orientamento liberale, non
calvinista..) pose le basi del diritto civile moderno. Grozio cercando il
fondamento di una norma giuridica che potesse predicarsi come universale si
pose il problema della sua validità non “Come se dio non ci fosse” ma “Anche
se dio non ci fosse”. Dunque non un “ut si deus non daretur” (o un “as if
God…”), ma” Etsi (etiam si) deus non daretur”.
La scelta di un avverbio cambia il senso complessivo. “Come se dio non ci
fosse” è inaccettabile certamente per un credente (si può mai chiedere ad un
credente di agire come se dio non esistesse?), ma anche per un non credente
che dovrebbe dare fondamento della propria scelta etica con una sorta di
“simulazione”, di “convenzione infondata”.
“Anche se…” propone invece ad entrambi, credente e ateo, di misurarsi con la
dimensione del dubbio, dell’incertezza, che non può che essere dimensione
esplorata sia da una fede seria e costantemente approfondita, sia da una
scelta atea… entrambe chiamate, proprio in nome di tale dimensione di
incertezza, a trovarne composizione rispettosa e dialogo.
Cito sempre, da ateo, un motto del Talmud che dice (pressappoco) “Il Signore
ha parlato, e io ho udito due voci..” e che disegna efficacemente la
dimensione dell’incertezza della permanete necessità dell’approfondimento, e
dunque (anche letteralmente) del dia-logo. Del resto nella Bibbia dio dice a
Mosè: “non vedrai mai il mio volto..”. (A proposito di iconoclastia…)Vorrei
dunque proporre, a chi si occupa di formazione, una interpretazione del
dia-logo, della tolleranza, del confronto, che non hanno la dimensione
luminosa (illuminata…) delle affermazioni del diritto, della legge, della
“naturalità” della ragione, ma quella faticosa dello “scarto”,
dell’incertezza, del dubbio, del non poter “guardare dio in faccia”, e del
dolore di tale fatica
Illuminismo e formazione.
Sotto questo profilo,
allora, lo sgomento della domanda “…ma come è stato possibile che giovani
nati, cresciuti, istruiti nella nostra società “illuminista” diventino
fanatici capaci di compiere ciò che hanno compiuto..?” perde il rischio di
ipocrisia e diventa interrogativo che colpisce direttamente chi si occupa di
istruzione, di scuole, di formazione…. Il ragionamento “politico”
rintraccerà e darà, se ne è consapevole, le risposte sul piano della
emarginazione sociale, della disuguaglianza, della esperienza di quotidiana
ingiustizia delle periferie della grandi metropoli multietniche e
multiculturali.
Ma che la ribellione contro l’ingiustizia, non solo acceda alla violenza (la
storia della lotta di classe non né fatta di pacifismo…) ma identifichi il
terreno religioso e si immedesimi con una guerra di religione contro gli
infedeli e che declini la violenza non in termini di lotta di massa ma di
terrorismo individuale, tutto ciò invece rende fondata la domanda iniziale:
“che cosa è accaduto nella formazione di questi giovani?”. Una domanda che
investe la formazione (e non solo la scuola, ovviamente) di tutte le nuove
generazioni.
Ma il terreno nel quale affondano le radici di questa domanda è di assai
complessa dissodatura. Provo a proporre una domanda parallela, confidando
che essa stimoli il pensiero dei lettori e la ricerca di risposte, al di là
della rielencazione (come non condividerla, ma rischia qui di essere
stereotipa) di richiami alla libertà di stampa, a quella di opinine, al
ruolo della satira, al rifiuto della violenza…ecc..
Prendiamo una vignetta del giornale satirico francese contro il quale si è
concentrata la violenza terrorista, Rappresenta, o lo vorrebbe, la trinità
(il nucleo dommatico di un cristiano) in questo modo: dio sodomizza Gesù che
a sua volta sodomizza lo Spirito Santo…
Ho scelto volutamente una vignetta (satirica?) che non ha come bersaglio
l’Islam.
Fatto salvo il repertorio di richiami alle diverse libertà, e quello alla
volterriana tolleranza, nonché il richiamo alla funzione del diritto e della
giustizia, ed non alla violenza della reazione individuale dell’offeso, a me
pare si possa riproporre esattamente la domanda “ma cosa è accaduto nella
formazione di queste persone, come è possibile che nate e cresciute e
acculturate nella nostra società illuminista e tollerante manifestino in
tale modo il proprio pensiero, o la propria arte, o il proprio animo...Da
dove può mai nascere tale violenza (in questo caso verbale, certamente…)
contro la fede di propri simili… in quali pieghe dell’anima o irrisolti
psicologici si alimenta tale violenza…?”. In questo caso, probabilmente
senza neppure la possibilità di invocare il piano politico-sociale della
emarginazione, della disuguaglianza, della povertà…
Riproposta nel nostro contesto di persone che si occupano di istruzione, di
scuola, di formazione, tale domanda diviene ricerca isomorfa a entrambi gli
esempi (certo incommensurabili sul piano della violenza, delle conseguenze
ecc…). Chi si occupa di formazione si chiederà comunque sgomento di fronte
ad entrambe le “casistiche” (se confrontate con la pretesa luce dei lumi
della nostra cultura..) dove stia, cosa procuri quello ”scarto”? o meglio
ancora (posto che “il male” sia componente ineliminabile dell’uomo) come e
cosa fare per contenere, limitare, ridurre i danni? O anche solo vedere,
guardare, diagnosticare, prevenire…
Io credo che, proprio falsificando il rischio dei fare di Voltaire un brand
e un neo successo editoriale, ma anche del richiamo all’illuminismo una
sorta di bandiera (di sventolio assai esile per altro, se basta una battuta
di papa Francesco a farla ammainare..) della nostra civiltà europea, quella
domanda ponga in termini radicali il nesso tra cultura, ragione, educazione
formazione: E dunque i compiti fondamentali della scuola (ma non solo…)
nella riproduzione sociale (particolarmente, ma non solo, delle nuove
generazioni).
Piuttosto che a Voltaire il mio pensiero va alla cultura tedesca.
Bildung e aufklarung, per le ragioni implicite in quanto sopra sono
riferimenti che ritengo più pertinenti quando si parli di istruzione e
formazione.
Rispetto all’illuminismo francese l’aufklarung tedesca non ha prodotto una
rivoluzione, ma nel collegamento con la bildung ha sviluppato una
sensibilità particolare verso una “istruzione” popolare capace di coniugare
la felicità degli individui e la sua ricerca, con una solidarietà sociale
per la quale il soggetto è ciò “che sa e dà” al contesto sociale di
riferimento.
Da Kant, a Goethe e il suo Meister, a Lessing. Ma, se il lettore lo
preferisce, il riferimento è all’illuminismo scozzese (So che gli amanti
delle “congiure nascoste” son pronti ad accusarmi di appartenenze
massoniche: le smentisco in via preventiva) .
Le differenze tra gli approcci sono comunque radicate nella dimensione
“individualista” del richiamo alla ragione e ai suoi lumi nella cultura
francese.
Dunque non solo questi ultimi sono il riferimento, ma lo è Bildung,
costruzione, formazione in senso stretto.
Chi si occupa e lavora per l’educazione sa per propria esperienza che i lumi
della ragione non esauriscono la sua missione, non rispondono alla esigenza
complessiva di costruzione del soggetto, alla necessità che esso trovi e
rielabori la sua posizione nel mondo.
Il riduzionismo razionalistico ha, sotto il profilo educativo, esiti
contraddittori, a volte perniciosi, sia rispetto al singolo soggetto, sia
nella rielaborazione culturale collettiva; può produrre come esito del suo
esclusivismo, la negazione del valore stesso della ragione (ci riconoscete
qualche vostro studente?). Del resto ciò è accaduto nella storia stessa del
pensiero (da Kant a Nietzsche), e a maggior ragione accade nella storia
della evoluzione del soggetto.
Adolescenti costretti a cibarsi di quest’unico ingrediente declineranno
volta a volta derive bulimiche verso il proprio desiderio reiterato nel
consumo senza compimento, o derive anoressiche assolutizzanti incapaci di
rielaborarlo e di riconnetterlo come ingrediente, tra gli altri (compreso il
proprio desiderio), della propria crescita e affermazione di autonomia.
Se Bildung è “costruzione”, allora la formazione dell’uomo implica sempre
una “potatura”, una ”ferita”, un “artificio”.
Tommaso dice “forma hominis, juxta propria pincipia..” dunque non secondo
la “propria natura” ma secondo una forma determinata “al di fuori”.
Per Marx è il “lavoro” (dunque lo sforzo, la fatica) il processo di
umanizzazione dell’uomo; e nella creazione di questa sua “seconda natura”
sta la ferita dell’alienazione.
Adorno usa ripetutamente termini come “mutilazione”, “storpiamento” per
indicare concretamente il processo di formazione, e guarda al “sistema della
cicatrici” (rileggere “Minima moralia”. Non dico invece, ma almeno accanto,
al riacquistato “Trattato sulla tolleranza”).
Del resto l’etno-antropologia
ci propone dovizie di esempi nei quali la “formazione”, l’acquisizione della
“adultità” si accompagna, in certe culture anche fisicamente, con la
ferita, la scarificazione. (E i piercing plurimi dei nostri adolescenti?).
E infine la castrazione (simbolica) non è forse la “topica” fondamentale
della costruzione del soggetto nell’approccio freudiano?.
Chi si occupi di formazione, sia che operi nella scuola e nell’istruzione,
sia che lavori nei media e nell’informazione, o comunque, per il ruolo ed il
lavoro che fa ha possibilità, grandi e men grandi, di influenzare e
determinare il senso comune, la cultura sociale condivisa (la funzione
“intellettuale, secondo Gramsci), porta questa pesante responsabilità.
Si misura innanzi tutto con i rischi del “riduzionismo” che riporta la
formazione stessa ad un percorso lineare. Un bel repertorio di dichiarazioni
di “diritti”, così apparentemente “naturali” e rassicuranti del benessere
(benestare) sociale, e la reiterazione convincente attraverso la
comunicazione, lo spot, il richiamo alle “educazioni”.
Misurarsi invece con quello scarto, con quella “ferita” che sta nel cuore
profondo della formazione è più complicato, più destabilizzante, reclama
responsabilità vere e partecipate, non elenchi e repertori di diritti
“naturali”.
In altro contributo su queste pagine sottolineavo che un docente non
esaurisce il suo lavoro e impegno con la “geometria” del curricolo, ma
sperimenta quotidianamente e in modo tanto più drammatico quanto più
profondamente viva il suo impegno, il rapporto con quella dimensione di
scarto, di ferita, di “potatura”, di castrazione simbolica che è il cuore
duro della formazione. E chi invece dedica esclusivamente la propria
attenzione alla geometria del curricolo finisce per pensare di avere di
fronte non giovani, preadolescenti o adolescenti reali, ma una sorta di
“idealtipo apollineo”, che, al peggio, andrà “convinto” , attraverso
opportune ”unità didattiche” ben progettate magari secondo le “indicazioni
ministeriali”, delle buone “ragioni”, e “naturali”, della cultura, della
scienza, del sapere, della “naturalità” del sistema dei diritti.[1]
Salvo contraddirle clamorosamente, appena fuori dal perimetro scolastico,
allo stadio, nei bar del quartiere con gli amici, o anche semplicemente
“twittando” sullo smartphone.
Giacobbe lotta per tutta la notte con l’angelo, anzi con dio stesso (Genesi
32, 23-33. Si perdonerà a un ateo come me l’invito a leggere la Bibbia?) E
non molla. Ne esce sciancato (lo storpiamento di Adorno), ma vincitore. “
Non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele, perché hai combattuto con dio e
con gli uomini e ne sei uscito vincitore”. E mentre lottava avvinto
all’avversario, e non lo lasciava andare, Giacobbe gli dice “non ti
lascerò se non mi avrai benedetto”. In altre parole combatte perché “si
dica bene di lui”…
C’è metafora più potente (nella nostra cultura. Credo vi sia traccia
assimilabile nel mito di Gilgamesh..) della “formazione” dell’uomo, del
valore e significato della cultura, della “fondazione” dell’impresa umana?
La vittoria dell’uomo su dio è segnata dalla “sciancatura”, dalla ferita
(chissà se il Voltaire che rifletteva sul dolore irrimediabile e
“sragionevole” del terremoto di Lisbona non avesse intuito proprio questo…);
e la lotta è per ”essere benedetto” dall’avversario, non per odio nei suoi
confronti.
E contemporaneamente l’esito della lotta vittoriosa è l’acquisizione di una
dimensione sociale e collettiva ”da ora in poi ti chiamerai Israele”. La
formazione compiuta (bildung) è in dimensione sociale, non individuale.
La cultura e il sapere non sono rapportabili con la natura, neppure quella
immaginifica nella sua “primordialità” (non è un caso se “pedagogista”
Rousseau, ne fece il fulcro contraddittorio della sua riflessione). Sono
invece “artificio”, costruzione. Dunque lotta, sciancatura, ferita. Segno
permanente che rimane nel tempo.
Il sapere
e la cultura sono una “seconda natura” dell’uomo, non solo non rapportabili
alla prima, ma “laceranti” rispetto ad essa.
Come ricordavo (provocando) ai miei studenti (tanti anni fa: si era
all’inizio delle sensibilità ecologiche e della loro vulgata mediatica) la
struttura portante dell’ecosistema è la catena alimentare: chi mangia e chi
è mangiato… se volete sviluppare una cultura ecologica misuratevi con tale
paradigma, e scoprirete che la cultura e la civiltà umana non solo sono
altro e ma anche incompatibili (a meno di essere nazisti..). O come dico
sempre ai fondamentalisti della biodiversità: dalla invenzione
dell’agricoltura (10-12 mila anni fa) circa l’80% della biomassa del pianeta
è ormai composta da sette o otto specie animali e poco più di specie
vegetali. Selezionate e riprodotte dall’uomo in questi millenni. Solo il
(poco) resto è “natura”. Dunque bene che la “cultura” dell’uomo si misuri
con la necessità di rispetto e riproduzione della “natura”, ma è un compito
culturale e scientifico: non c’è nulla di “naturale”. Fa parte di quello che
Adorno chiama il “sistema delle cicatrici”. La natura-natura è il terremoto
di Lisbona che sconvolge Voltaire…
Ma quella “seconda natura” proprio perché è lacerazione, è nella storia; è
“storicamente determinata”; quanto a dire che non vi è predicazione
“liberatoria” che non si misuri con la storia dell’uomo e con le sue
contraddizioni. Non c’è “repertorio di diritti” che sostituisca la
“giustizia sociale”. Battersi per i diritti non è la stessa cosa che
battersi per una società più giusta. E questo è il piano del rapporto tra
formazione e polis.
Domande di fondo, le cui risposte (tentativi di..) lascio ai lettori: come,
nella formazione, rielaborare la ferita, la mancanza, la storpiatura; la
dimensione dionisiaca e notturna dell’itinerario di formazione, e
falsificare l’illusione apollinea della inevitabilità naturale del sapere e
della cultura? Come rielaborare “simbolicamente” la ferita a fronte della
realtà di ferite “vere”, patite nella carne e nello spirito (esclusione,
selezione, emarginazione), in modo che la stessa ribellione contro
l’ingiustizia conquisti una sua “disciplina”? Come rielaborare la dimensione
sociale collettiva della formazione, dalla “fratria” (ormai la scuola è il
solo luogo di incontro con “fratelli”, scomparsi dal contesto familiare),
all’esperienza concreta del valore sociale di “ciò che sei e sai” per
ciascuno, rispetto al contesto di riferimento (P. es. sono anni che richiamo
l’idea del servizio civile obbligatorio..).
Due sole notazioni finali di un ragionamento difficile e complesso. Una
seria, l’altra meno.
Si dice, guardando le immagini terribili di esecuzioni a freddo, a
bruciapelo, senza esitazioni: “devono avere avuto un addestramento
militare”… Certo. A base di video giochi e di carneficine virtuali. La
virtualizzazione della realtà è un potente strumento di addestramento a
ridurre l’impatto, fisico e psicologico, della realtà. Un cazzotto (vero)
innesca un sistema di retroazione sensibile: ne porti il dolore sulle nocche
per settimane… Non è un caso che una battuta di Francesco sia stata
sufficiente a smontare tante elaborazioni…certo usa il linguaggio semplice
della vita quotidiana, certo è spontaneo e immediato fino all’infortunio
(apparente) mediatico. Ma è il primo papa della storia gesuita e, credetemi,
nulla, neppure una parola, è rielaborata a caso…Sa quel che dice e vuol dire
a differenza di tanti mosconi ronzanti che cercano di interpretare.
Un videogioco rovescia fiumi di sangue senza retroazioni se non sul piano
emozionale di “accumulo di punteggio”. Bisogna pensarci in una formazione
che, giustamente, tende ad integrare al massimo le potenzialità delle
tecnologie della informazione, e i vantaggi della virtualizzazione.
Virtualizzazione è processo nettamente diverso (opposto) da quello di
“rielaborazione simbolica”.
La notazione meno seria è dedicata all’amico Tiriticco: “tutta colpa di
Voltaire” era un modo di dire usato dai “benpensanti” durante la
Restaurazione. Ma è anche un verso della canzoncina ironica che Hugo mette
in bocca a Gavroche, il fanciullo barricadiero de “I miserabili”. A
proposito dell’esercizio dell’ironia e della satira.
Bisognerebbe decidere quale versione adottare.
[1] Ho sviluppato più ampiamente l’argomento in Franco De Anna, “La/le geometrie del curricolo”, in “La scuola e l’uomo”, (periodico dell’UCIIM,) n. 7-8, Luglio agosto 2014. Che la rivista cattolica ospiti il contributo di un ateo dichiarato mi pare un bell’esempio di tutto quanto andiamo dicendo