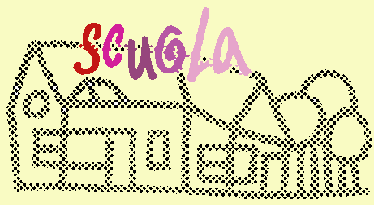 |
PavoneRisorse |
(29.09.2014)
Scuola,
istituzione della Repubblica
di Enrico Bottero
Il mio
articolo a commento del documento del Governo dal titolo “La buona Scuola” ha
suscitato le riflessioni di altri commentatori che scrivono su questo sito (v.
Franco De Anna in
http://www.pavonerisorse.it/buonascuola/supermercato.htm).
Colgo dunque l’occasione per svolgere a mia volta qualche commento e qualche
approfondimento sui temi in discussione. Nel mio articolo “Buona scuola?”,
scrivevo:
«Come
vedremo dall’analisi che segue, il documento è mosso da due postulati che, anche
se non esplicitamente dichiarati (non lo potrebbero essere vista la loro
radicalità e, forse, incostituzionalità), lo attraversano da cima a fondo:
lo
scopo della scuola è quello di preparare al mondo produttivo. Essa non guarda
più (non apertamente, ma di fatto) alla sua funzione universale e di riduzione
delle disuguaglianze ma si concentra fin dai primi ordini sulla preparazione al
mondo del lavoro e la valorizzazione delle eccellenze;
la conseguenza del primo postulato è che lo Stato, garante del patto di
cittadinanza e perciò per sua natura super partes, si ritrae dal campo
dell’educazione e limita la sua funzione al compito di creare le condizioni
perché gli attori sociali (scuole autonome, imprese, fondazioni, volontariato,
ecc.) si organizzino per raggiungere lo scopo di cui al punto 1. La scuola non è
più un’Istituzione e neppure un servizio realmente universale ma un Impresa al
servizio di altre imprese (e dunque del lavoro di domani, come suggerisce il
titolo di uno dei capitoli, “Fondata sul lavoro”, che allude alla Costituzione
proprio nel momento in cui se ne allontana)».
(Il mio documento completo all’indirizzo http://www.enricobottero.com/insegnare/wp-content/uploads/2013/11/BUONA-SCUOLA.pdf
Quando
parlo di postulati mi riferisco naturalmente a quelli che starebbero alla base
del documento governativo, non ai miei. Quando utilizzo il termine “postulati”,
non penso poi alla geometria euclidea, ma lo utilizzo secondo un’accezione
comune, nel significato di “principi”, “idee di fondo”. È noto, infatti, che
linguaggio comune e linguaggio specialistico scientifico non attribuiscono lo
stesso significato ai medesimi termini. Precisazione banale, ma necessaria.
La questione dei “postulati” o, se si preferisce, dei “principi” rinvia a
questioni di fondo. Il progetto di riforma della scuola, il progetto
dell’insegnante per un gruppo di allievi sono sempre ispirati da un idea: che
tipo di società e/o che tipo di soggetto si vorrebbe contribuire a formare? Un
progetto c’è naturalmente anche nel documento “La buona scuola”, anche se fosse
al di là della piena consapevolezza degli estensori. Anzitutto è molto attento
al mezzo più che al messaggio (oggi non a caso, in politica, ha sempre più
successo chi sa “raccontare una storia”, fare story telling), che tende a
convincere gli utenti consumatori più che a spiegare e far capire. E’
prevedibile che la maggior parte degli italiani fonderà il suo giudizio sulle
scarne ed orientate affermazioni dei media, in particolare della
televisione. E’dunque dovere di un lettore attento cercare di capire meglio,
offrendo ad altri un’analisi più approfondita. È ciò che non solo io ma molti
altri hanno fatto, naturalmente anche con conclusioni molto diverse dalle mie.
Nel mio documento ho toccato i vari punti del testo governativo (nuova carriera
degli insegnanti, riforma del precariato riforma e trasparenza del sovrasistema,
modifica dei curricoli, ecc.) e ne ho tratto una conclusione. La mia non è
dunque una petizione di principio ma il frutto di un’analisi. Aggiungo che
l’idea che ispira il documento del Governo è abbastanza diffusa ed appartiene ad
un dibattito di lunga data sulla funzione della scuola (funzione universale o
funzione professionalizzante?).
È da notare che le proposte contenute nel documento “La buona scuola” seguono
di poco le Raccomandazioni del Consiglio europeo sul programma di stabilità del
2014 in cui, tra l’altro, si legge:
“L'insegnamento è una
professione caratterizzata da un percorso di carriera unico e attualmente da
prospettive limitate di sviluppo professionale. La diversificazione della
carriera dei docenti, la cui progressione deve essere meglio correlata al merito
e alle competenze, associata ad una valutazione generalizzata del sistema
educativo, potrebbero tradursi in migliori risultati della scuola”.
Il
testo completo del documento all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/csr2014_italy_it.pdf
È dunque legittimo pensare che la riforma della scuola proposta costituisca una sorta di obolo pagato alla politica attuale dell’Europa al fine di acquisire credibilità e credito in quella sede. Si tratta di una cessione di sovranità, come altre ce ne sono state in questi anni. Sappiamo ben che tutto ciò è l’effetto di una realtà che sta sotto gli occhi di tutti: il potere (non democraticamente eletto) è globale mentre la politica rimane confinata negli Stati nazionali. Gli Stati nazionali, gli unici poteri ad avere legittimazione democratica, sono inevitabilmente ricettacoli dei problemi e dei rischi che si producono a livello globale (Baumann, 2013, 19).
La mia
valutazione del documento del Governo può essere contestata nel merito, ma non
tacciata di pregiudizio, di idee precostituite. Colpisce infatti l’affermazione
secondo cui con le critiche dell’autonomia nella versione che si è realizzata
sarei “oggettivamente”, se non soggettivamente, alleato degli avversari
ideologici e passatisti dell’autonomia scolastica. Si tratta di dichiarazioni
inaccettabili perché mirano a togliere credibilità all’interlocutore invece di
contestarlo nel merito. Purtroppo questa incapacità di tollerare la critica,
che richiama antiche pratiche, caratterizza anche l’attuale capo del governo.
Nel mio articolo ho ripreso indirettamente un tema centrale, quello relativo
alle idee e principi sulla scuola, sull’educazione, e sul loro rapporto con la
democrazia. Su questo tema rinvio al documento di Philippe Meirieu, presente sul
mio sito e in cui mi ritrovo (se poi anche altri, come mi auguro, si
pronunceranno sulla questione dei principi ciò gioverà alla discussione):
http://www.enricobottero.com/insegnare/wp-content/uploads/2013/11/Meirieu.educazione-democratica.pdf
L’idea di fondo è che la
scuola non ha per compito principale quello di formare al mondo del lavoro
adattandosi alla società (molti, a partire da Confindustria, la pensano così,
sposando la tesi althusseriana della “riproduzione sociale” ma ribaltandola in
senso positivo). La scuola è chiamata a formare la libertà del soggetto, un
soggetto che imparerà a vivere insieme agli altri. Essa risponde al principio di
educabilità (“tutti sono educabili”) ma nella prospettiva dell’emancipazione
dell’altro e non della sua sottomissione (un rischio sempre presente in ogni
attività educativa). In una società democratica l’educazione è anche educazione
alla democrazia perché “essa forma cittadini capaci di comprendere il mondo, di
definire insieme il bene comune e lavorare a una maggiore solidarietà tra gli
uomini e tra i popoli” (Meirieu). In questo senso, la scuola non è solo un
servizio ma anche un’Istituzione. L’Istituzione è qualcosa di più di un
servizio, è una realtà che gode di particolare tutela essendo depositaria di
valori fondanti la società e la convivenza civile. Il suo valore non sta solo
nella soddisfazione degli utenti ma anche e soprattutto nella sua fedeltà ad
alcuni principi fondanti: costruzione della cittadinanza, riduzione delle
disuguaglianze, ecc. In quanto Istituzione, questi principi fondanti non
appartengono ai singoli utenti ma a tutta la comunità nazionale.
Nel momento in cui il soggetto cessa di essere caratterizzato come membro o
cittadino di una società politica ma viene percepito solo come lavoratore o
consumatore l’istruzione perde di importanza perché subordinata all’attività
produttiva e allo sviluppo del benessere economico (cfr. Touraine, 1998, 284).
Quest’ultima linea di tendenza, affermatasi soprattutto negli anni Novanta, ha
permeato il dibattito da cui è scaturita l’autonomia (v. Bottero, 2003, 85 – 97)
anche su sollecitazione della nascente Europa. Sull’autonomia scolastica come
si è realizzata in Italia ho già svolto un’analisi a cui rinvio per
approfondimenti:
http://www.enricobottero.com/insegnare/wp-content/uploads/2013/11/AUTONOMIA-SCOLASTICA-IN-ITALIA.pdf
(Autonomia scolastica: breve cronistoria di una riforma” ).
La
riforma nasceva da un’esigenza giusta. Era necessario far funzionare meglio la
scuola pubblica diventata ormai una struttura elefantiaca difficilmente
governabile. Essa, si diceva giustamente, non poteva continuare ad operare con
un’organizzazione centralistica e burocratica organizzativa secondo criteri
legati al puro adempimento di vincoli formali. L’esigenza di decentramento era
anche legata al fatto che da tempo si includeva nel “sistema formativo” una
pluralità di soggetti pubblici e privati del territorio.
L’esigenza era giusta perché l’obiettivo della scuola repubblicana legato alla
riduzione delle disuguaglianze non deve rimanere astratto ma mirare alle
disuguaglianze di fatto per correggerle attivamente. Era dunque necessaria una
maggiore autonomia delle scuole e degli insegnanti nell’organizzazione
dell’insegnamento. La grande sfida della scuola del futuro resta infatti quello
della “differenziazione didattica”. La gestione delle differenze non può essere
espulsa attribuendola ai compiti a casa o a forme di sostegno individuale solo
per i casi più difficili. E’ la sfida della scuola di domani.
La riforma introdotta alla fine del secolo scorso ha scelto altre strade. Il
sovrasistema viene lasciato pressoché intatto con le sue storture (con un
surplus di ingerenza del potere politico nelle nomine dirigenziali). Alle
scuole viene attribuita autonomia amministrativa ed organizzativa, molto poco,
nei fatti, quella didattica. Ad esse sono concesse sempre meno risorse (umane e
finanziarie) mentre vengono ridotti i vincoli per ottenerle da altre fonti.
Viene indebolita la zonizzazione anche nelle scuole di base mettendo così in
moto un processo di competizione tra scuole. La logica è evidente e risponde
sostanzialmente ad un avvicinamento al modello anglosassone (organi collegiali a
parte, che sono rimasti): una scuola gestita con logiche manageriali che, grazie
alla competizione con le altre, riuscirebbe a migliorare il servizio. Oggi la
proposta del governo aggiunge un altro tassello: la competizione tra gli
insegnanti (v. riforma delle carriere), ai quali, nel frattempo, con decisione
del Governo avallata dai sindacati, era stata tolta l’obbligatorietà della
formazione (presente, in forma diretta o indiretta, negli altri Paesi europei)
eliminando di fatto un sistema pubblico nazionale della formazione in servizio
(una scelta grave che non mancherà di avere effetti negativi). Se sarà
reintrodotta sarà senza dubbio un fatto positivo.
Per spiegare queste scelte si deve anche riflettere su una nostra caratteristica nazionale: la sfiducia nello Stato (cattivo) vissuto come controparte della società civile (buona). Questa sfiducia ha ragioni storiche molto complesse con diverse articolazioni e motivazioni nelle diverse zone del Paese. Il problema è che la sfiducia nello Stato non è compensata da altri luoghi in cui viene identificato lo “spazio pubblico”. Pensare di smantellare la struttura dello Stato e i suoi poteri (v. titolo V) affidando ad altre istituzioni l’organizzazione dell’interesse collettivo ha già rivelato i suoi limiti (v. ad esempio la gestione delle Regioni, cui qualcuno vorrebbe attribuire anche la gestione dell’istruzione). Qualcuno pensa di affidare tutto all’Europa ma, come sappiamo, l’Europa politica con istituzioni rappresentative non esiste ancora. Neppure la democrazia partecipativa, dal basso, (movimenti e comunità), peraltro ancora poco diffusa anche per il montante individualismo sociale, può sopperire al mancato funzionamento di una struttura nazionale di regolazione (né può sostituire la democrazia rappresentativa). Il vero problema da affrontare è la tendenza ad eliminare i confini tra spazio pubblico e spazio privato, uno dei rischi della moderna organizzazione politica (Urbinati, 2012), a vantaggio di quello più forte (in Italia, il privato). Il rischio di ridurre al minimo lo spazio pubblico è aggravato in Italia dalla nostra storia localistica unita all’assenza di una “religione civile”. Se è così, oggi smantellare lo Stato ed indebolire lo Stato sociale avrebbe la conseguenza di consegnare questi spazi ad altri interessi, di qualunque parte od orientamento essi siano. In questo contesto anche il sistema formativo verrebbe meno al suo compito istituzionale di formare cittadini allo spazio collettivo (che, ricordiamolo, non è solo quello la comunità locale ma anche la collettività nazionale).
Non resta dunque che, a Costituzione vigente (autonomia compresa), riorganizzare lo spazio pubblico nella scuola (che non è solo lo Stato, ma parte dallo Stato). E’ un compito difficile, visti gli insuccessi del passato nel riformare la macchina pubblica, ma dobbiamo provare. Nel mio documento sull’ “Autonomia scolastica in Italia” ho formulato alcune proposte a cui rinvio. Il documento del Governo, a parte alcuni elementi di cui ho già detto, va purtroppo in altra direzione.
Nota a margine
Finora ci siamo mossi sul terreno della politica dell’educazione, certamente importante. La pedagogia, però, ha a che fare soprattutto con le pratiche che realizzano educatori ed insegnanti, sia di quelli per cui la scuola pubblica ha un valore di emancipazione culturale e di formazione universale sia di quelli che pensano prima di tutto all’efficacia professionale e sociale della formazione scolastica. Gli insegnanti chiedono a chi elabora politiche educative la possibilità di intervenire nella quotidianità dell’azione educativa, quando l’allievo, quell’allievo, resiste e fa sorgere difficoltà al progetto formativo elaborato dalla scuola (una resistenza, una tensione, che è consustanziale alla pedagogia praticata e con cui bisogna fare i conti). L’errore più comune quando ci si mette ad argomentare di politiche della scuola è quello di pensare che la politica educativa non sia solo una precondizione ma sia già la soluzione di ciò che verrà dopo. Di qui la tendenza a pensare gli insegnanti come semplici servitori di strumenti di valutazione e pilotaggio della macchina scolastica. Noi non abbiamo però bisogno di insegnanti “proletarizzati”, ma di “insegnanti ricercatori”, coinvolti in una formazione continua, sempre impegnati nella ricerca sui loro saperi, capaci di suscitare la voglia di apprendere. La pedagogia sta infatti lì e i suoi esiti dipendono prima di tutto dai suoi attori primari. Viene da pensare, dunque, che non sia possibile fare riforme vere senza di loro.
Bibliografia
Zygmun
Baumann (2013), Danni collaterali. Diseguaglianze sociali nell’età globale,
Roma- Bari, Laterza.
Enrico Bottero (2003), Il sapere didattico, Bologna, Clueb.
Alain Touraine (1998), Libertà, uguaglianza, diversità, Milano, Il
Saggiatore.
Nadia Urbinati (2012), Liberi e uguali : contro l'ideologia individualista,
Roma - Bari, Laterza.