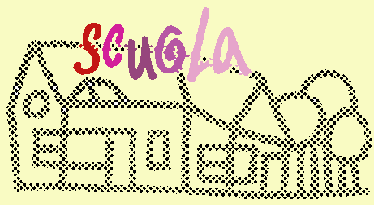 |
Direzione didattica di Pavone Canavese |
a cura di Aluisi Tosolini
Zigmunt Bauman
La società dell'incertezza
Il Mulino, 1999
Nel 1929 Sigmund Freud pubblica "
Il disagio della civiltà": una impietosa analisi della società moderna che, tra principio di piacere e principio di realtà aveva scelto il secondo. Ovvero l’ordine, la regolazione: "L’uomo civile - scriveva Freud - ha scambiato una parte delle sue possibilità di felicità per un po’ di sicurezza". Il disagio nasceva, secondo Freud da un eccesso di ordine e dalla sua inseparabile compagna: la morte della libertà.
A 70 anni dall’analisi di Freud "la libertà individuale - scrive Bauman - regna sovrana; è il valore in base al quale ogni altro valore deve essere valutato e la misura con cui la saggezza di ogni norma e decisione sovra-individuale va confrontata" (pag 9).Siamo nel tempo della deregulation dove il principio di piacere regna sovrano. Così: "gli uomini e le donne postmoderni scambiano una parte delle loro possibilità di sicurezza per un po’ di felicità". E "il disagio della postmodernità nasce da un genere di libertà nella ricerca del piacere che assegna uno spazio troppo limitato alla sicurezza individuale".
Da qui il confronto con il disagio dei nostri progenitori moderni: "Se la noia e la monotonia pervadono le giornate di coloro che inseguono la sicurezza, l’insonnia e gli incubi infestano le notti di chi persegue la libertà. In entrambi i casi, la felicità va perduta" (pag. 10).
2. Dalla libertà all’incertezza
Ogni gioco prevede vincitori e vinti (e sul gioco segnalo un bel volume - paradossale e
freudiano sin dal titolo - del filosofo Pier Aldo Rovatti: Il paiolo bucato,
Milano, Cortina, 1998).
Ma nel gioco della libertà - segnala argutamente Bauman - le cose si fanno più
complesse: "Chi ha perso si consola con la speranza di vincere la prossima volta,
mentre la gioia del vincitore è offuscata dal presentimento della perdita". Per
entrambi la libertà significa che nulla è stabile ma tutto è incerto. Ma
l’incertezza è portatrice di messaggi differenti: ai perdenti dice che non tutto è
ancora perduto (così continuano a giocare trasformandosi in carnefici di se stessi),
mentre ai vincenti sussurra che ogni trionfo è precario.
3. Catalogo delle paure postmoderne
Uno dei saggi di Bauman indaga la tipologia delle paure postmoderne. Come si sa Michel
Foucault - sulle orme del Panopticon di Jeremy Bentham - sostiene che tutte le istituzioni
della modernità erano fabbriche dell’ordine e della certezza. Si trattasse di
scuole, ospedali, eserciti, il loro ruolo era definire l’idoneità sociale degli
individui e, in caso di inidoneità, doveva provvedere a isolare tali individui in
apposite istituzioni totalitarie (manicomi, prigioni, ecc).
Nel tempo della postmodernità non esistono più istituzioni simili o, perlomeno, quelle
esistenti sono attraversate da mortali metastasi.
Oggi l’incertezza non viene più vinta dalla fabbriche dell’ordine della
modernità ma deve essere vinta da ogni individui con i propri mezzi: il timore della
devianza (oggi non esiste più devianza: non esistendo più alcun faro dell’ordine
tutto è permesso) è sostituito dalla paura della inadeguatezza. Inadeguatezza che
significa: incapacità di acquisire la forma e l’immagine desiderate, difficoltà di
rimanere sempre in movimento. Difficoltà a mantenersi sempre flessibili e pronti ad
assumere modelli di comportamento differenti, di essere allo stesso tempo argilla
plasmabile e abile scultore.
Tra le conseguenze del venir meno delle figure del sovraintendente, del capo,
dell’insegnante (clasiche figure dell’ordine moderno) la più importate riguarda
il fatto che con loro sparisce anche la loro capacità di liberare dal peso della
responsabilità. Se spariscono le fabbriche ed i sacerdoti dell’ordine ognuno è
responsabile di se stesso, delle sue azioni. Ogni individuo diventa "controllore di
se stesso". Certo: tutti sono liberi, libero nella prigione che si è costruito lui
stesso.
4. Dall’incertezza alle generose offerte del mercato
Per concludere questo passaggio: alla privatizzazione della gestione dell’incertezza corrisponde la forza del mercato. Se infatti io mi sento inadeguato - personalmente inadeguato - sarò certamente ansioso di cogliere le molteplici proposte che il mercato mi fa al fine di poter migliorare la mia adeguatezza. Proposte che - stavolta - raccolgo spontaneamente, senza alcuna coercizione esterna e senza nessuna opera di indottrinamento ad opera di altri.
Esempio semplice semplice: se io mi sono sentito inadeguato quando 15 anni fa ho capito
che l’informatica avrebbe cambiato radicalmente il mondo non ho avuto bisogno di
nessuna coercizione esterna per decidere di spendere moltissime risorse personali per
assumere competenza in questo campo. O ancora: se percepisco che il mio cellulare è
inadeguato (ovvero che, ad esempio, sono tagliato fuori dal mondo a causa del fatto che il
mio tacs non spedisce messaggi) sarò io stesso che correrò a cercare un nuovo telefonino
che migliori la mia adeguatezza al mondo. E... guarda caso.... di questi telefonini ve ne
sono sul mercato a centinaia. E tantissimi di diversi ce ne saranno fra un mese, o due, o
tre. Giusto per non fermarsi, per dover costringermi a continuare a cercare sensazioni
nuove..
Gli esempi che fa Bauman sono altri e riguardano in particolare il corpo (a cui dedica un
intero saggio: il corpo come compito). Corpo che non deve più essere abile al lavoro
(come avveniva nel tempo moderno e come ancora si ostinano a certificare gli uffici di
leva: abile e arruolato, oppure "revisione" - come le automobili!!! - o
riformato - che fa rima con riformatorio....: tanto per dire come le fabbriche
dell’ordine siano sopravvissute alla fine del loro tempo) ma deve essere un capace
recettore di sensazioni. Da qui la legge del fitnes, della palestra (dove ci si
auto-tortura per raggiungere una forma adeguata: cose che se te le fa fare
l’insegnante di educazione fisica minimo lo ammazzi...), della necessità di
accogliere e assimilare nuove stimolazioni, di fare raccolta di sensazioni. Sensazioni che
vanno sempre rinnovate: non ci si può fermare mai, al punto che, contraddittoriamente, il
fine diventa la ricerca delle sensazioni per le sensazioni non per quello che ognuna di
essa sarebbe capace di offrire. Da qui le corse insensate, il non fermarsi mai, il non
gustare nulla, il correre, il "farsi" (.... altro giorno ascoltavo furtivamente
i discorsi di un gruppo di amici che si scambiavano le impressioni sulle vacanze. Uno
dice: "in 6 giorni ci siamo fatti Germania, Olanda, Francia e Svizzera".
Ve li immaginate? E immagino che il tutto sia stato rigorosamente filmato e fotografato
per una serata con amici in cui iniziare a programmare come farsi il prossimo
viaggio - trip?-). Insomma, la figura del turista (a cui Bauman dedica il saggio "Da
pellegrino a turista" riprendendo argomentazioni su cui
ci siamo già soffermati
5. Libertà: mia o altrui?
Scrive Bauman: "una conseguenze universalmente riconosciuta della progressiva
emancipazione della libertà individuale di scelta (deregulation), è la divisione sempre
più profonda fra i ricchi e chi non possiede nulla" (pag. 18).
Abbiamo più volte ragionato - durante i nostri compiti per le vacanze - su questo tema.
Ovvero sulle conseguenze della deregulation e in particolare sulla crisi dello stato
sociale (cfr. Bordieu), oppure il rapporto 10
dell’
bertà, Differenza, Solidarietà
A partire da questo dato Bauman compie due significative riflessioni:
a.
Tagliare e restringere le libertà degli esclusi non aggiunge nulla alla libertà di chi è libero: al contrario, sottrae a molti altri la possibilità di sentirsi liberi... La strada dei tagli al welfare può condurre ovunque tranne che a una società di individui liberi: anzi per le esigenze della libertà, è come imboccare un vicolo cieco. La libertà individuale di chi è già libero non guadagna molto, in termini di risorse, da questa eliminazione. L’unico esito assicurato sembra essere la percezione di una sensazione sempre più universale e condivisa di insicurezza e incertezza. Dimenticando che la libertà di chi è libero richiede, per così dire, la libertà di tutti poiché la libertà è una relazione sociale. (pp. 18-19)b.
Quale politica è necessaria nel tempo della postmedernità? La risposta di Bauman è illuminante: "La politica che si ispira alla saggezza postmoderna si orienta verso una continua ri-affermazione del diritto degli individui liberi a perpetuare e garantire le condizioni della loro libertà. Ma per fare questo ha bisogno di essere guidata dal triplice principio di Libertà, Differenza e Solidarietà ove solidarietà è la condizione necessarie e il contributo collettivo essenziale alla vitalità della libertà e della differenza. Ma se il mondo postmoderno è capace di generare da se stesso Libertà e Differenza lo stesso non si può dire per la Solidarietà. Ma senza solidarietà nessuna libertà è sicura mentre le differenze e il tipo di politica dell’identità che tendono a generare conducono, non di rado, alla interiorizzazione dell’oppressione.Qui sta
il paradosso della postmodernità: per realizzare appieno libertà e differenza essa necessita di solidarietà. Di responsabilità di fronte al volto dell’Altro. L’Altro che ci è sempre straniero (e allo straniero Bauman dedica due saggi: La produzione e l’annullamento dello straniero; Lo straniero rivisitante e rivisitato)Solo così l’incertezza e l’inquietudine postmoderne potranno - forse - sedarsi.
Aluisi Tosolini