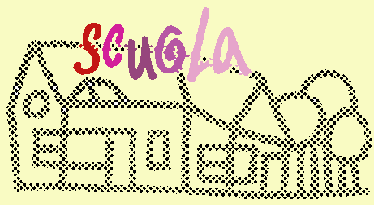 |
PavoneRisorse |
Ancora sulle
competenze: come valutarle
di Franco De Anna
Torno sull’argomento dopo il mio precedente intervento, perché mi pare che nell’insieme delle iniziative editoriali, di dibattito culturale e scientifico, di prese di posizione politico-sindacali, emergano alcune questioni che meritano approfondimenti e precisazioni.
Della complessa e ambigua semantica del termine “competenza”….
Il nostro (di noi
docenti, dirigenti scolastici ecc…) appartenere alla Pubblica
Amministrazione dovrebbe insegnarci qualche cosa su tale ambiguità.
Nella PA la “competenza” assegnata ad uno specifico ufficio o persona,
non corrisponde affatto a ciò che quella persona o quell’ufficio “sa
fare”, ma a ciò che è sua “prerogativa” assegnata. Per quanti uffici o
persone “competenti” di svolgere un certo lavoro, di condurre una
pratica nella PA, spesso dobbiamo concludere che non sanno e non ne sono
capaci o con grandi limitazioni di efficacia e produttività?...L’ufficio
“competente” in realtà non ha “competenze”. Ma ciò che conta per la PA è
avere riempito una casella del “manuale operativo” con una attribuzione
formale di compiti.
A partire da tale banale considerazione, confesso qualche sospetto
quando vedo una parte della PA (sia pure quella preposta al governo
della Scuola) parlare e discettare con disinvoltura assertiva di
“competenze”. Coltivo (confesso il pregiudizio) una sotterranea
convinzione che la traduzione di tale ambiguità semantica nel “manuale
operativo” consista nel predisporre una casistica, un repertorio di
classificatori, delle schede tassonomiche delle diverse occorrenze.
Riempite le caselle delle schede, il compito è assolto.
Ma quali “competenze” reali supportano l’ufficio o la persona (nel
nostro caso il docente) il cui compito assegnato sia di misurare le
competenze di altri? Come si riempie “la scheda”?
Analogo spessore di
ambiguità di significati ha il termine “certificazione” ( e già ne
accennavo nell’articolo citato). Per la PA “certificare” ha il
significato formale del “rilasciare un certificato”.
Cioè una “dichiarazione” formale che attesta, autorizza, sancisce… (di
nuovo un “modulo”?)
Una eredità della storia delle funzioni della Pubblica Amministrazione:
quando esse si limitavano al carattere “autorizzativo e prescrittivo”
dei suoi provvedimenti. (ma siamo grosso modo a Cavour, e quel modello
ci trasciniamo con successive e complesse stratificazioni storico
culturali). Una PA che produce autorizzazioni, in connessione con
diritti “politici e civili”, ha una “cultura” affatto diversa da una PA
che produce “servizi!” alla cittadinanza ed ai sui diritti “sociali”.
“
Certificare” significa in tale caso garantire pertinenza,
appropriatezza, qualità, efficacia, efficienza di tale “produzione”,
non produrre una” carta” attestante.
Se faccio il “valutatore” per la guida Michelin o per il Gambero Rosso
non posso semplicemente attestare che una certa pietanza di un cuoco “mi
piace”, e neppure che “non fa male e rispetta la natura”. Devo misurarmi
con la cultura culinaria, la tradizione, locale e internazionale, le
possibili interpretazioni, anche innovative…. Devo possedere una
“cultura” dell’oggetto da valutare sulla cui pertinenza si fonda la
possibilità (per altro sempre da sottoporre a verifica con opportuna
supervisione) del mio essere in grado di “certificare”.
Per stare al nostro caso: se mi si chiede di “certificare le competenze”
non posso che muovere da una approfondita cultura relativa alle
competenze stesse, a ciò che si intenda con il termine.
Qui la cosa si complica per il fatto (tutt’altro che trascurabile) che
si chiede al “cuoco” (al docente) di “certificare” il suo stesso
prodotto (le “competenze” di colui che egli conosce come “discente”.
L’espressione può apparire contorta ma se ne darà conto in seguito).
Accenno a tale contraddizione (tenuta sotterranea nello stesso dibattito
culturale e pedagogico) ricordando che essa era ben presente ai “nostri
padri”. Un esempio: la “certificazione” fondamentale rilasciata nel
nostro sistema di istruzione fu per anni il “diploma di maturità” ( con
“valore legale”, quindi per la PA la quintessenza della
“certificazione”. Mi si passi la battuta: quanti “autentici riformisti”
attuali rivendicano tali assunti con piena coerenza…). Ebbene, con una
coerenza certo superiore alla attuale, la Commissione di maturità era
fatta tutta (tranne uno interno) da docenti esterni (non era il cuoco a
certificare se stesso) e il candidato era sentito su “tutto” lo spettro
della sua condizione di “discente”. Sarà più che discutibile ed obsoleto
il modello, ma aveva una sua “avvertita” consapevolezza del significato
del “certificare”, che è diverso da quello del “valutare”.
Vista la sua maggiore coerenza perché non ritornare sui passi? Perché la
realtà si è incaricata di falsificare l’ipotesi: personalmente ho fatto
quegli esami di maturità (1964), e già traballavano (la decostruzione fu
nel 1969). Ma chi allora vi partecipava rappresentava meno del 30% dei
giovani in età. (Certo: ero un privilegiato..) Oggi è più che
raddoppiato. La dimensione del problema è diversa, e la “quantità” (a
volte) trasforma la “qualità”. (Non mi ricordo più chi l’ha detto….).
Soprattutto: l’istruzione superiore estesa all’universo delle
generazioni aventi diritto, ha modificato radicalmente il suon
significato sociale. E noi manteniamo invece stratificate le
significazioni antiche…
Competenza: una categoria meticcia
Ho ricordato, con il
fastidio di qualcuno, l’origine non- scolastica, non-pedagogica, della
categoria di “competenza”. Nasce in contesto di impresa. Per alcuni una
sorta di “peccato mortale”. Non per me. Anzi. Trovo sempre di grande
interesse e sollecitazione intellettuale il “rimescolamento” di culture,
sensibilità, parole, significati. Il “meticciamento” è condizione di
sviluppo, di evoluzione. Il potenziale evolutivo, come per le specie, si
fonda sulla variabilità. E, in genere, gli ibridi sono più affascinanti
dei “puri”. La sola avvertenza quando si ha a che fare con l’ibridazione
è di produrre ibridi fecondi. Altrimenti per quanto bello ed
affascinante sia il meticcio, se non è in grado di riprodursi rimane un
“episodio in sè stesso limitato”. Interessante, ma senza futuro. O
meglio, volendo garantirsi i vantaggi dell’ibrido infecondo, occorre
investire in modo finalizzato e costante nella ibridazione. Come per i
muli.
Ma forse oggi l’apprezzamento delle qualità del mulo, rispetto ai
genitori, è un poco in decadenza…
Voglio solamente
esplicitare i riferimenti, visto che vi si sorvola nel dibattito
corrente.
L’elaborazione europea più significativa sul tema delle “competenze”
rideclinate in contesto di formazione (non necessariamente scolastica…
anzi) si inscrive nella fase di gestione Delors, di grande rilevanza
politico culturale, ma probabilmente già troppo lontana (1985-1995) per
la “corta veduta” del nostro dibattito. Le datazioni mostrano
semplicemente quanto “siamo in ritardo”. E, per intenderci: in ritardo
sia per aderire e ottemperare, sia per eccepire e distinguere.
Questi i documenti
“Insegnare e apprendere, verso la società cognitiva”, Libro bianco sull’istruzione. Bruxelles, Commissione delle Comunità Europee (1995)
“Portare a compimento l’Europa tramite l’Istruzione e la Formazione”, rapporto del Gruppo di Riflessione sull’istruzione e la formazione, Riassunto e raccomandazioni, Commissione Europea (1996)
“Apprendere nella società dell’informazione”, Piano d’azione per un’iniziativa europea nell’istruzione 1996-1998, Bruxelles, Commissione delle Comuinità Europee (1996)
“Per un’Europa della conoscenza”, Comunicazione della Commissione Europea Commissione Europea (1997)
“Memorandum sull’istruzione e la formazione nell’arco di tutta la vita”, Bruxelles, Commissione delle Comunità Europee (2000).
In parallelo voglio ricordare che nel 1983, ad opera di un consistente gruppo di grandi imprese (Nokia, Suez- Lyonnaise des Eaux, Renault, Saint-Gobain, Petrofina, Nestlé, British Airways, ThyssenKrupp, TOTAL, Royal Philips Electronics, Solvay, Deutsche Telekom, FIAT, Telecom Italia, ENI ecc) si diede vita all’ERT (European Round Table of Industrialists) con compiti di analisi e proposte sullo stato dell’economia europea, perché si rompesse l’immobilismo e si avviasse un massiccio processo di modernizzazione dell’industria di base in Europa. L’ERT, negli anni successivi, avanzò alla UE una serie di proposte che andavano dalla privatizzazione di vitali settori pubblici, alla riforme dei sistemi pensionistici, alla (de)regolamentazione del mercato del lavoro, alla riforma dei sistemi di istruzione pubblica. Nel 1987 l’ERT diede vita ad un “gruppo di lavoro sull’educazione” che rimase in attività fino al 1999, e da esso provengono numerose sollecitazioni reinterpretate negli anni successivi (compresa la sensibilità sul tema competenze)
Anche in tale caso mi limito a citare i documenti più rilevanti in merito a quest’ultimo punto.
“Educazione e competenza in Europa” (gennaio 1989)
“L’istruzione per gli europei. Verso la società della conoscenza” (Marzo 1995)
“Investire in conoscenza – L’integrazione della tecnologia nella scuola europea” (Febbraio 1997)
In linea con tali elaborazioni la Confindustria europea presentò
“Per una scuola di qualità: il punto di vista degli imprenditori”(Londra, 8 febbraio 2000).
In tutti questi documenti si introduce e rielabora la categoria di “competenze” come riferimento fondamentale della qualificazione del “fattore umano” nel processo di riconversione/ristrutturazione del sistema economico/industriale europeo. Nessuno di questi documenti ha come origine il campo della “ricerca educativa” o della “cultura pedagogica”.
Altrove sintetizzai
l’intera argomentazione sostenendo che la categoria della “competenza” è
rappresentativa della problematica del “valore di scambio” della cultura
e dell’istruzione nel rapporto di lavoro, in un sistema economico che
incorpora quote crescenti di cultura e istruzione entro il processo
produttivo stesso (ma lo fa, non ostante il mito della “società della
conoscenza”, ovviamente, con forte filtro selettivo).
Altra cosa è il “valore incondizionato” (il “valore assoluto” della
cultura e del sapere) con il quale si misura quotidianamente il lavoro
del docente e la problematica squisitamente pedagogica del “fare
scuola”.
La dialettica del “doppio valore” dovrebbe rappresentare un orizzonte,
difficile ma insostituibile, della professione docente nella “scuola di
tutti e per tutti”, in questa fase storica, e “dominare” sia le derive
economiciste (ben al di là delle impaurite e frustrate pregiudiziali
contro la cultura di impresa), sia, al contrario, le nostalgie di una
cultura sempre interpretata come “otium” e sganciata dai paradigmi del
lavoro e dello sviluppo economico, ma in realtà offerta ai “pochi”
privilegiati che del lavoro e dello sviluppo sono “i beneficiari”, più o
meno insediati e inseriti nella catena di scambio, ma non gli
interpreti. (Vedere il tormentone culturale sul Liceo Classico e il suo
trascurato primato, che sarebbe da ridere per gli autorevoli interventi,
se il pianto non toccasse ad altri. Quelli esclusi. E io sto con gli
altri..)
Ho riportato
l’elenco precedente perché mi pare che l’origine “economica” della
categorizzazione di “competenza” sia come lasciata dietro l’orizzonte.
Posso comprendere il “pudore” (o l’inconsapevolezza..) di tale
confinamento. Ma credo che ciò costituisca una inavvertita ma drastica
limitazione alla piena consapevolezza e comprensione della questione che
si pone sempre quando una sollecitazione/suggestione proveniente da
altra cultura si offre alla traduzione di quella che ci è più prossima.
Se vogliamo riconoscere come valore l’incrocio, il meticciamento di
modelli, culture, linguaggi, occorre porre cura massima nelle operazioni
di trasferimento e traduzione (tradurre è sempre un poco tradire,
direbbe Calvino).
E, nel valorizzare “l’ibrido”, come ricordato più sopra, curare che esso
sia fertile e non il risultato di una semplice operazione di “incrocio”.
Il cuoco non certifica, ma valuta
Riprendendo la
metafora proposta dianzi: non si può affidare al cuoco il compito di
darsi le “stelle” della guida Michelin (e neppure ai clienti… può farlo
solo chi abbia una accertata e supervisionata cultura culinaria…) o ma
certo il cuoco valuta. Guai se non lo facesse. Assaggia, corregge in
corso d’opera, aggiunge condimento, segue e assiste all’opera sua… Il
senso della metafora è evidente: non solo segnala la funzione
dell’autovalutazione come strumento essenziale della cultura
organizzativa di una scuola, ma consente di delineare una dislocazione
concettuale fondamentale tra valutazione e certificazione.
In tanto è efficace l’azione di valutazione condotta dal cuoco, in
quanto è esercitata su condizioni, variabili e risorse che egli
padroneggia e che dunque è in grado di modificare e sulle quali può
influire. Certo con limitazioni: se manca sale posso aggiungerne. Se il
sale è troppo si apre un problema, non si può togliere: le patate
assorbono l’eccesso di sale, ma l’aggiunta di patate cambia la ricetta….
Paiono banalità, ma sembrano sfuggire ad autorevoli commentatori..
Per tornare a noi: la distinzione tra valutazione e certificazione mi
pare argomentata a sufficienza. A mio parere occorrerà anche solamente
registrare il linguaggio ed usare con cautela il termine
“certificazione” (possiamo sempre “metterci d’accordo” sul significato,
purché sia chiaro il carattere “convenzionale” dell’accordo. Ma se
qualcuno si prende troppo sul serio, la convenzione salta..).
Vedo con conforto che un vecchio amico come Mario Castoldi, sia pure con
minore vis polemica della mia (ma è questione di carattere: Mario è
molto più equilibrato) sottolinea la sequenzialità e priorità
concettuale tra valutazione e certificazione. Come non essere d’accordo?
Come pensare di disporre di un “certificatore” che non si sia neppure
misurato con il “cosa” valutare? Come pensare che sia sufficiente
produrre alcune (più o meno sensate) schede e scale di classificazione
(da A a D. Che non fa molta differenza con da 0 a 10: a parte
l’antipatia per i numeri… Ogni scala deve essere trasferibile in
un’altra…)?
Ma al di sotto di tale consapevolezza, opera un’altra e assai più
significativa.
Dal punto di vista di un “docente ideale”, capace di affrontare
congiuntamente il compito di utilizzare appropriati strumenti di misura
(tecnica) e di rielaborare inferenze e diagnosi sulla base della quali
formulare giudizi (anima), alla base del processo di valutazione e che
ne legittima l’esercizio rispetto al soggetto interlocutore (il
discente), sta la consapevolezza della padronanza degli strumenti di
intervento per correggere, migliorare, costruire alternative, offrire
occasioni e indirizzi all’interlocutore che ci si offre come discente
(tecnica +anima).
Per gli amanti della “consolazione delle parole” o delle parole
consolanti, ciò si chiama “valutazione formativa” (mai inganno verbale
fu più efficace e deviante, contrastando la “crudezza” del valutare con
la consolazione dell’indicare contemporaneamente “la salvezza”. Che sia
un derivato della nostra cultura cattolica?). So che ci si sta
impegnando per dimostrare che la ”valutazione delle competenze” può
essere iscritta nel paradigma della valutazione formativa (un esempio
più che autorevole: Giancarlo Cerini). Ma, a parte la declinazione
banale ( in contesto pedagogico, la valutazione è sempre indicazione di
un modello verso cui tendere per migliorare… e infatti il problema è il
“modello”) la verità è incomoda: se c’è un esempio di valutazione che in
sé limita fortemente la componente “formativa” è proprio la “valutazione
delle competenze”, specie se estesa impropriamente alle età di più
intenso e significativo sviluppo del soggetto (le prime età scolari). Le
ragioni di tali affermazioni di seguito.
Le competenze come oggetto “multivariabile”
Molti ed autorevoli
commentatori (penso a G. Cerini, M. Spinosi, M. Tiriticco, M. Castoldi…
e me ne sfugge qualcuno a cui chiedo scusa per la mancata citazione) si
sono misurati con l’impresa di dare al termine “competenze” una adeguata
definizione. Medesima cosa ho provato io stesso nell’articolo ospitato
in queste pagine
(http://www.pavonerisorse.it/riforma/valutazione/voti_competenze.htm ).
Non mi interessa qui confrontare le definizioni e neppure sottolineare
le maggiori o minori ampiezze. Credo che un elemento unifichi le diverse
proposte definitorie.
Il costrutto di “competenza” è multivariabile: comprende nel suo arco
definitorio elementi assai diversi tra loro (cito: abilità, capacità,
esperienze, attitudini, conoscenze, motivazioni, responsabilità..). La
“competenza si propone come una “sintesi”, operata sul substrato
psico-antropologico del soggetto, di tale insieme multivariabile.
Nulla di grave né di concettualmente impervio: pensate a quando
scegliete un idraulico. A parità di formazione professionale, a parità
di “borsa degli attrezzi”, finanche a parità di tariffe, scegliete Uno
piuttosto che Altro. A presiedere alla scelta sta una “sintesi” non
sempre esplicita analiticamente, di considerazioni diverse, su ciascuna
delle variabili. Non esclusa quella della abilità del rapporto con il
cliente.
Vi pare superficiale l’argomentazione? Ma di questo stiamo parlando.”
L’imprenditorialità” è una delle componenti del repertorio delle
competenze di cittadinanza elaborate dalla UE nel quadro delle
qualifiche.
Ma qui interessa sottolineare il carattere di sintesi di molte variabili
che il termine competenze ha, qualunque sia la definizione che si
scelga.
Alcune di tali variabili sono intrinseche al rapporto educativo (“quel”
rapporto educativo, non è né l’unico, né sempre il più rilevante..) che
si instaura tra docente e discente e che è caratteristico del sistema di
istruzione nel quale operiamo: formale, organizzato secondo un modello
di pubblica amministrazione, istituzionalizzato negli obiettivi e nelle
procedure, guidato da istanze di riproduzione culturale esplicitate
(che si chiamino “programmi” o che si chiamino “indicazioni”. Non son
la medesima cosa, ma per il ragionamento che stiamo conducendo si
equivalgono).
Altre variabili non lo sono. Pre-esistono al rapporto educativo; sono
estranee ad esso; sono parallele ma non interrogate da esso…
Abilità, attitudini, esperienze, motivazioni… Un docente trova, nel suo
“discente,” gran parte di tali variabili o pre-determinate da una storia
del soggetto sulla quale egli nulla può, se non interpretare ciò che è
già accaduto, o (penso alle “attitudini”) fare un intenso e
investigativo lavoro di scoperta di ciò che la scuola “normale” non
interroga (noi interroghiamo sempre su ciò che il discente “non sa”,
perché tendiamo ad assimilarlo ad un modello idealtipico di ciò che
sa/deve sapere, che si tratti di “programmi” o “indicazioni”). E sulle
“esperienze” sappiamo che l’impostazione storica della nostra scuola,
per quante correzioni possiamo fare, riproduce una cultura didattica
lontana dalla scuola dell’esperienza, lontana da Dewey, così come da
Maria Montessori.
In buona sostanza: se ci riferiamo al modello tradizionale di
interpretazione del lavoro del docente, della relazione educativa
docente/discente, dei modelli di organizzazione della didattica, dei
valori interpretati e attuati nella pratica valutativa, l’azione di
padronanza del docente si esercita prevalentemente su una ed una sola
delle variabili costitutive delle competenze: le conoscenze.
E’ la variabile “plastica”. Quella sulla quale tradizionalmente il
docente può influire attraverso il suo lavoro di formazione (per
adeguato o meno che sia..) attraverso l’apprendimento
Per le altre che compongono le competenze (abilità, attitudini,
capacità, esperienze, motivazioni…), dovrà esercitare capacità di
scoperta, rilevazione, incentivazione attraverso l’esercizio e la messa
a disposizione di occasioni (la costruzione di esperienze, possibilmente
fuori dal range delle “indicazioni”)… ma non ha strumenti di
esercizio di “padronanza” a meno di capovolgere/sconvolgere il modello
di cultura professionale e didattica consolidato.
Nulla di grave: credo che se un docente sia in grado di esercitare
effettiva padronanza su una componente essenziale della sintesi
costituita dalle “competenze”, quale sono “le conoscenze”, gran parte
del suo lavoro sia compiuto.
Il problema si pone quando si chiede al docente di essere valutatore e
finanche “certificatore” di variabili che non sono in sua “padronanza”,
e dunque sulle quali non può influire attraverso il suo lavoro
In tale caso il carattere “formativo” della valutazione è puro richiamo
ideologico. Ma non mi scandalizza, anzi. Può essere una occasione per
disvelare la falsa coscienza di una scuola che predica il carattere
formativo della valutazione ( e magari lo usa strumentalmente contro le
rilevazioni standardizzate dei livelli di apprendimento) e
contemporaneamente si disfa di quasi un terzo dei suoi “discenti”.
Ciò che è sicuro è il fatto che si chiede al docente una prestazione
professionale che esorbita la relazione educativa quale si è costituita
prevalentemente nella nostra scuola e lungo la sua storia. (Con
differenziali tra diversi ordini di scuola: la primaria è da sempre più
attenta alle dinamiche proprie del soggetto).
Valutare le competenze richiede
competenze multiformi
La complessità delle
variabili che presiedono alla definizione di “competenze” può anche
essere affrontata in un lavoro (apprezzabile) di confronto con quanto
definito/predicato nel “modello” operativo costituito da programmi o
indicazioni. Si tratta comunque di un livello prezioso di analisi e di
proposta, non ostante le diverse cosmesi linguistiche ( per esempio,
nelle indicazioni, non le competenze ma i “traguardi” per le
competenze… E ne capisco e apprezzo la mediazione. Ma poi in certe
circostanze, come la “certificazione”, la mediazione dei “traguardi” si
rivela per ciò che è...)
Ma al fondo residua una problematica non esorcizzabile.
Se la complessità multivariabile costitutiva del costrutto di
“competenza” trova la sua sintesi sul substrato psico antropologico del
soggetto, che interpreta molto di più del “discente” modellizzato sia
nella cultura scolastica prevalente, sia nelle innovazioni di programmi
e/o indicazioni, e se il docente-cuoco è chiamato ad esercitare la
propria valutazione ( e finanche certificazione) su elementi di cui non
ha padronanza diretta, occorrerà dotare il docente di competenze e
di strumentazione di carattere psicodiagnostico che affianchino, se ve
ne sono di adeguate, quelle di valutazione degli apprendimenti e delle
conoscenze.
Altrimenti si tratterà di “compilare schede”. E sarà fatto, non ho
dubbi. Ma perdendo una occasione per mettere in discussione l’intera
cultura della valutazione della scuola italiana.
I documenti ministeriali e la loro complessità
Alcuni interlocutori
(penso all’amico Tiriticco) se la prendono con la complessità dei
documenti (circolari, linee guida, allegati..) proposti dal MIUR e
leggono tale complessità in chiave di rimando ai docenti della
responsabilità di interpretare un fronte innovativo come la valutazione
delle competenze. Altri come Aladino Tognon, sottolineano tale
complessità come tratto positivo: il problema che abbiamo di fronte non
è risolvibile con un report standard o con una scheda.
Sono, in questo caso, più vicino ad Aladino. Ma non riesco a controllare
una certa malizia. In effetti il provvedimento dell’Amministrazione è
corredato da un apparato analitico di tutto rispetto e che rimanda una
consapevolezza del problema nella sua complessità.
Ma tale immagine di approfondimento analitico è contraddetta da due
elementi cruciali.
Il primo è l’estensione arrischiata e pericolosa della valutazione delle
competenze ad età scolari fortemente contrassegnate da velocità e
differenziali di sviluppo che poco si accordano con le “scadenze
ordinamentali”. La valutazione delle competenze in uscita dalla
primaria è, rispetto alla stessa consapevolezza mostrata dai documenti
ministeriali, una “simulazione” nella quale i pericoli (pre-figurare nei
“documenti scolastici” una immagine del soggetto “inchiodato” ad una
fase della sua evoluzione) sono più consistenti dei possibili vantaggi
(una diagnostica accurata del soggetto stesso o e delle sue prospettive
evolutive).
Il secondo è il “precipitato” di una predicata, declarata e intensa
attività diagnostica connessa alla attenzione alle competenze, in un
apparato classificatorio (schede, scale di valutazione..) che rischia di
autonomizzarsi (anche per il solo fatto che le schede diventeranno
“obbligatorie”) dalla stesso impegno diagnostico.
Insomma: abbiamo a che fare con un (contraddittorio e complesso) oggetto
che rimette in discussione la cultura valutativa della nostra scuola e,
per il suo esorbitare dalle variabili comunemente interpretate nella
padronanza dei docenti, pone interrogativi radicali sullo stesso modo
di “fare scuola” ( dalla valorizzazione della caratteristiche
individuali, alla promozione dell’esperienza, alla scoperta delle
abilità ed attitudini “non contemplate” nel modello idealtipico di
discente..) e dunque sulla cultura didattica mediamente espressa nel
nostro sistema di istruzione.
Mi piacerebbe che si evitassero due rischi: da un lato quello del “ il
Ministero scarica un problema in più sui docenti..”. Dall’altro una
esegesi puntigliosa e “avverbiale” dei documenti ministeriali che
confortasse la metabolizzazione della novità, residuando che “in fondo
non c’è nulla che non sappiamo già fare e che non sia previsto nelle
“nuove” indicazioni”. Non sono vere entrambe le cose.