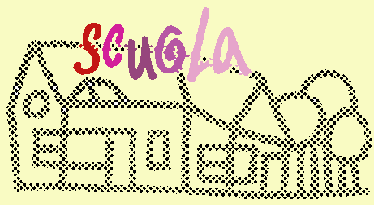 |
Direzione didattica di Pavone Canavese |
(06.04.2008)
Le competenze
relazionali
di Stefano Stefanel
Il Dirigente scolastico
nella scuola dell’autonomia deve avere delle elevate competenze relazionali,
perché svolge una professione che lo pone a contato diretto e pressoché
quotidiano con gli utenti e gli stakeholder. Se si analizza il profilo
del Dirigente scolastico e lo si mette in relazione con le altre dirigenze dello
Stato o del settore privato appaiono evidenti due disfunzioni molto forti:
a) un Dirigente scolastico deve governare, con il solo ausilio professionale
del Dsga, da 100 a 300 persone senza figure intermedie professionali di
supporto;
b) un Dirigente scolastico deve rapportarsi in prima persona anche con alunni,
genitori, enti locali, ecc. in una serie di rapporti e relazioni che è anche
solo difficile elencare.
Il Dirigente scolastico dovrebbe avere una competenza relazionale, che fa il paio con quella comunicativa, estremamente delicata in uno snodo cruciale che le altre dirigenze non conoscono: può essere, infatti, costretto a prendere decisioni in tempo reale o a fornire opinioni che vengono percepite come definitive, o a dare risposte che l’utenza non accetta mai come interlocutorie. Tutto questo perché il Dirigente scolastico ha un rapporto sempre diretto con utenti e stakeholder, che le altre dirigenze difficilmente hanno. Nessuno si sognerebbe di entrare in un Ospedale e di pretendere seduta stante di parlare con il Direttore sanitario, mentre è normale che chiunque voglia parlare immediatamente con il Dirigente scolastico. Le competenze relazionali sono definibili solo all’interno di un ampio spettro di attività e spaziano da quelle istituzionali a quelle di carattere più occasionale.
Vediamo comunque le varie tipologie di relazioni che il Dirigente scolastico si trova a dover allacciare, mettendole in relazione con le varie tipologie di utenza:
o Relazioni con i docenti. Come non esiste una chiara tipologia di docente, così non esiste neppure una relazione-tipo da tenere. Vanno isolati due punti: il dirigente scolastico non è un collega; il dirigente scolastico è comunque la controparte nel tavolo della trattativa sindacale. Fatte queste due precisazioni tutto il resto deve collegarsi più al buon senso che alla tipologia relazionale. I docenti non amano essere richiamati, mentre amano essere lodati. Bisogna dunque stare attenti a calibrare i propri interventi e a non dare l’idea che non ci sia attenzione, ma solo controllo.
o Relazione con il proprio staff. Lo staff del Dirigente scolastico è una variabile dipendente dalla storia di ogni singola scuola. Ci sono Dirigenti scolastici che di fatto non hanno uno staff, in quanto si sono limitati a confermare quello precedente con cui non vanno d’accordo e che non hanno il coraggio di rimuovere. Ci sono viceversa Dirigenti scolastici che contano su staff elefantiaci, in quanto inglobano nelle collaborazioni tutto il personale che a qualche titolo svolge funzioni di coordinamento e raccordo. Le figure dei collaboratori del Dirigente scolastico hanno un profilo vago e compiti legati alla singola scuola, mentre le funzioni strumentali spesso solo referenti di piccole progettualità. Il Dirigente scolastico senza staff non va da nessuna parte, ma proprio per questo la relazione con lo staff è fondamentale così come la definizione di compiti ed ambiti chiari. Lo staff spesso non interagisce con il Dsga e gli Assistenti amministrativi in maniera costruttiva, anche perché chi lavora nell’amministrazione non è disponibile a capire che i docenti non hanno competenze amministrative e non devono averle, mentre i docenti non sono disponibili a perdonare il perdurante desiderio dell’amministrazione scolastica di prediligere il formalismo burocratico alla sostanza didattica. In questo difficile rapporto si inserisce lo staff del Dirigente scolastico in tutte le sue forme e composizioni. L’equilibrio di rapporto e l’equilibrio di compiti può rendere lo staff veramente efficiente, ma solo se tutto si svolge nell’ambito della chiarezza e della trasparenza.
o Relazione con il Direttore dei servizi generali e amministrativi. E’ tra tutte la relazione forse più delicata. I Dsga tendenzialmente ritengono che la soluzione giusta per la gestione di una scuola sarebbe una equipollenza di poteri all’interno di settori pienamente autonomi e interdipendenti. La maggior parte dei Dsga ritiene la figura del Dirigente come una figura di tipo “didattico”, mentre pensa che il “reale” controllo sui conti già di per sé indichi uno sbilanciamento nella gerarchia. Poiché così non è nei fatti il Dirigente deve essere così abile e attento da non farsi scavalcare dal desiderio di potere autonomo del Dsga da un lato e dall’altro dal tentativo di considerare il Dsga come un semplice sottoposto. Nella relazione con il Dsga il Dirigente deve mettere le sue armi psicologiche migliori, partendo dall’idea che la categoria non gradisce l’attuale struttura gerarchica delle scuole e tende a ritagliarsi fette di autonomia, che però sono prive delle responsabilità del Dirigente. Il lato psicologico e quello formale devono compenetrarsi e un Dirigente deve utilizzare le sue capacità relazionali per evitare ad ogni costo la collisione.
o Relazione con il personale di segreteria. Il personale di segreteria per sua formazione non riesce a condividere, nella larga maggioranza dei casi, la visione della scuola del Dirigente scolastico. Legato ad una cultura degli adempimenti chiede solo che l’adempimento venga cambiato, ma non è attrezzato per adeguarsi al sistema della governance. La stabilità burocratica porta quel personale a relazionarsi più volentieri con le carte piuttosto che con le persone e questo produce spesso un aumento del carico burocratico al di là di quanto voglia il Dirigente scolastico. Se un Dirigente è preso dalla mania di emanare circolari, il personale di segreteria svolgerà un ruolo attivo nella redazione delle circolari, ma passivo nel controllo della loro reale disseminazione. Il Dirigente scolastico deve perciò attivare strategie per cercare di modificare l’atteggiamento di base, che è legato alla cultura degli adempimenti e non a quella del risultato. La questione non è banale, perché il personale di segreteria nell’ambito dell’autonomia è il settore più esposto sul fronte della rendicontazione dei risultati e dei servizi diretti all’utenza.
o Relazione con i collaboratori scolastici. Il Dirigente scolastico davanti ai collaboratori scolastici si trova, impotente, a constatare un divario assoluto tra domanda e offerta. I collaboratori scolastici sono legati fortemente alla propria sindacalizzazione, ai rigidi mansionari contrattuali, alla propria disponibilità. Il Dirigente scolastico ha il compito di portare la flessibilità nella scuola e di adeguare il servizio alle esigenze dell’utenza. Poiché la distanza tra le due missioni è abissale la convivenza di solito è ottima: troppa strada da percorrere con mezzi inadeguati non invita al viaggio, per cui si cerca di ricondurre tutto nell’alveo di quell’ente di ragione che è l’intensificazione della prestazione, che non può esistere nei fatti, ma che invece esiste nei contratti. La contrattualizzazione del lavoro dei collaboratori scolastici, che nulla ha a che vedere con la didattica e gli apprendimenti o la rendicontazione, è un passaggio forzato cui volentieri i Dirigenti scolastici rinuncerebbero, ma la strada delle cooperative è impervia visto il modo con cui lo Stato trasferisce le risorse. Resta dunque il buonsenso e un certo controllo sul personale, ma questo non ha niente a che vedere con un servizio efficiente ed efficace e ancora meno con la risposta alle esigenze dell’utenza (preaccoglienza, orari flessibili, atipicità degli interventi, gestione non rigida del servizio, ottimizzazione dei tempi di lavoro, ecc.).
o Relazione con i genitori. Poiché non esiste una tipologia di genitore chiara ed esportabile non può neppure esistere una relazione tipo da tenere con i genitori. L’atteggiamento è però fondamentale: è necessario non essere né troppo accomodanti, né spicci e liquidatori. Dopotutto i genitori affidano alla scuola il loro bene maggiore: sia che lo si valuti in senso affettivo, sia che lo si valuti come un “investimento”, il figlio è per tutti il primo obiettivo della propria vita. Non c’è quindi mediazione che possa risolvere conflitti che partono da una cattiva relazione. Bisogna sempre tenere conto che una buona parte dei docenti delle scuole secondarie considera i voti bassi, la durezza, il raggiungimento di standard che stanno nella testa del docente ma non sono precisati sulla carta, le bocciature, ecc. (cioè tutto l’armamentario della vecchia scuola che ci ha portati al punto in cui siamo) come elementi di serietà e non come strumenti di dispersione. Questo le famiglie non lo possono accettare, perché comunque provengono dalle scuole dell’infanzia ed elementari dove il deficit dell’alunno è quasi sempre un problema della scuola. Nella relazione con i genitori va tenuto sempre presente che esiste un limite che il genitore giustamente non vuole varcare ed è quello di considerare il proprio figlio come un perdente che non vuole fare nulla per migliorare. Le pressanti richieste fatte alle famiglie di supportare i propri figli partono dalla superba certezza che la scuola stia facendo tutto il possibile e la famiglia no. Il Dirigente scolastico in questa relazione deve mettere tutto l’ascolto, l’attenzione e la chiarezza di cui è capace, per evitare che il servizio scolastico scivoli sul versante del rapporto con i genitori. Inoltre deve sempre cercare di capire il punto di vista del genitore, che non è mosso da acredine verso la scuola, ma dalla preoccupazione per l’avvenire del figlio. Questo perché comunque il Dirigente scolastico tende ad incontrare i genitori solo quando sorgono i problemi: è molto difficile che i genitori vogliano parlare con il Dirigente scolastico su cose che vanno bene (anzi in quel caso i genitori ritengono che il merito sia tutto degli insegnanti e il Dirigente scolastico non c’entri per nulla). Un buon elemento relazionale è quello di proporre incontri di formazione e informazione diretti ai genitori tenuti dal Dirigente scolastico per spiegare che cos’è la scuola e cosa fa, invertendo così la tendenza a convocare i genitori a scuola soltanto per parlare di bullismo, crisi adolescenziale, rapporti genitori-figli, ecc. La scuola deve imparare a spiegarsi e lo può fare solo attraverso il Dirigente scolastico.
o Relazione con gli alunni. E’ la competenza più importante ed anche la più colpevolmente sottovalutata. Il Dirigente scolastico riceve la sua legittimazione solo dal dover dirigere un servizio educativo e formativo a favore di alunni (allievi o studenti). Ma troppo spesso dimentica questa missione o la sottovaluta e tra lui e gli alunni si apre quasi un fossato. Ci sono molte scuole in cui gli alunni non sanno nemmeno il nome del Dirigente scolastico e lo considerano qualcosa di lontano o punitivo: quello che ti richiama, quello che fa i discorsi d’apertura, quello che viene a prendere gli applausi per quello che hanno realizzato studenti e insegnanti. Credo che l’obiettivo principale sia quello di invertire questa tendenza e far capire a tutti gli alunni che comunque c’è qualcuno che sta lavorando per loro. In cinese il direttore della scuola si chiama Xiao Zhang (o qualcosa di simile), che vuol dire più o meno: “Quello che aiuta a studiare meglio”.
o Relazione con i colleghi. In questo tipo di relazione bisogna partire dall’idea che nessun Dirigente vuol sentire una lezione e in linea di massima si confronta solo per farsi dare ragione. Difficilmente un Dirigente riconosce in un collega una fonte autorevole, a meno che il collega non sia lontano e quindi non frequentato o che il collega sia noto o detenga qualche potere sindacale. La relazione più costruttiva è quella di rendersi utile e far sentire che anche l’altro è utile: una qualsiasi gerarchia in un mondo di pari è di per sé perdente.
o Relazione con gli Uffici scolastici. Il Dirigente scolastico deve partire dal dubbio che gli Uffici scolastici provinciali e regionali siano nemici dell’autonomia e in qualche modo la vogliano limitare. La perdita di potere centrale non ha coinciso con una reale difesa della dirigenza da parte dello Stato e ancora oggi molti Dirigenti sono in balia degli Uffici scolastici, abituati ad oberarli di schede, richieste, imposizioni, minacce, ecc. Gli Uffici scolastici non sono a supporto dell’autonomia, ma a principale conservazione di se stessi e questo il Dirigente lo deve sempre tenere presente allorché interagisce con questi Uffici. Difficilmente poi il Direttore generale interloquisce direttamente con i Dirigenti, preferendo che a farlo siano gli altri Dirigenti. Si attua così una palese asimmetria di cui la relazione risente in quanto il Dirigente si trova a discutere o contrattare con figure intermedie e questo già di per se lo colloca su un piano di inferiorità. Proprio per questo una cosa da fare è non fornire mai agli Uffici informazioni che non hanno richiesto: poiché è poco chiaro che uso fanno delle informazioni che richiedono è molto pericoloso per la stabilità della propria scuola fornire informazioni non richieste, che rischiano di innescare processi difficili da governare.
o Relazione con i Sindacati. I rapporti tra i Sindacati e i Dirigenti scolastici in questo momento sono pessimi. Proprio per questo le relazioni devono essere buone e distese e improntate alla massima disponibilità unilaterale. Nessun Dirigente può aspettarsi nulla dai Sindacati, ma essere disponibili e attenti ai problemi del personale può aiutare se non altro a non trasformare i cattivi rapporti in guai giudiziari. L’eccesso di contrattazione e la poca disponibilità sindacale a definire criteri invece che ad entrare nello specifico della gestione e dell’organizzazione deve portare il Dirigente scolastico ad avere un occhio di riguardo per i Sindacati cercando di eliminare il contenzioso. L’obiettivo del Dirigente nella relazione con i Sindacati deve essere quello di raffreddare le posizioni, evitando problemi di sistema.
o Relazione con gli organi di controllo. Laddove il Dirigente scolastico si rapporta con un Organismo di controllo (Revisori dei conti, Asl, Ispettorato del lavoro, ecc.) deve sapere che la più probabile relazione è di tipo sanzionatorio. Per questo deve essere rigoroso, limitarsi a rispondere alle domande, non cercare vicinanze o colloquialità, non eccedere con le informazioni o le spiegazioni. In questo caso uno stretto formalismo è ciò che meglio alimenta una relazione corretta, visto che gli Organismi di controllo si relazionano non attraverso persone, ma attraverso funzioni.
o Relazione con i mass media. Il Dirigente scolastico deve avere sempre in mente che la scuola per i mass media è un territorio di caccia. Per un qualsiasi organo di informazione una scuola allagata, dei ragazzi che spacciano droga, insegnanti che si denudano, maestre pedofile e via enumerando sono notizie in grado di far impennare l’interesse. Le buone pratiche, la quotidianità perfetta, l’equilibrio e l’armonia non sono argomenti interessanti. Se una scuola riceve una benemerenza questa notizia può trovare spazio tra le brevi, se in una scuola un’insegnante sferra un pugno ad un alunno si va sul notiziario nazionale. Le capacità relazionali del Dirigente scolastico nei confronti dei mezzi di comunicazione devono trovare la loro origine in un’attenta analisi dello specifico di ogni mezzo di comunicazione. Il Dirigente scolastico si trova con la sua scuola in un territorio e in un contesto e per questo è necessario che conosca bene qual è il target di notizie che vengono comunemente date a livello locale, per evitare di essere il bersaglio della morbosità giornalistica. Non è un problema da poco, perché la capacità dirompente della comunicazione giornalistica può interferire e non poco con la vita della scuola (vedi riquadro)
o Relazione con gli Enti locali. Nel rapporto con gli Enti locali bisogna tener presente sempre che l’Ente locale è al tempo stesso un organo amministrativo ed un organo elettivo. Nell’Ente locale si condensano l’amministrazione e la politica ed ogni decisione presa è destinata a pesare sul consenso, soprattutto nei piccoli centri. Per questo è importante avere relazioni distese e accomodanti, non portare mai la scuola verso litigi o rivendicazioni forti, non chiedere cioè ai politici di non fare il loro mestiere o di non essere preoccupati dal consenso.
o Relazione con coloro che a vario titolo hanno rapporti con la scuola. Alla fine è necessario comprendere in una sorta di omnibus tutti i possibili interlocutori con cui un Dirigente scolastico deve relazionarsi. Non è, infatti, possibile distinguere ulteriori tipologie vista la varietà di interlocutori attivi e passivi del Dirigente scolastico (fornitori, rappresentanti, politici, presidenti di associazioni, formatori, università, ecc.). Buona norma sarebbe non respingere nessuno, ma saper inserire nel poco tempo a disposizione il maggior numero di relazioni possibili, in modo da comprendere le esigenze e le proposte e interloquire con tutti coloro che cercano nella scuola un interlocutore. Compito non facile, ma comunque compreso nel profilo della dirigenza, che deve essere una cerniera tra l’istituzione e la società.
|
LE SCUOLE DEVONO IMPARARE A COMUNICARE (Tratto da Il Dirigente scolastico nella scuola dell’autonomia, di Stefano Stefanel, Spaggiari, Parma 2007 Nella società della conoscenza la comunicazione è fondamentale. Ma le scuole stanno diventando sempre più autoreferenziali e incapaci di rispondere alle precise domande che vengono loro fatte dalla società. Sul Corriere della sera dell’11 maggio 2007 Francesco Giavazzi, che il giorno prima aveva partecipato al Forum dedicato alla scuola in un Istituto superiore milanese, ha attaccato la Dirigente scolastica: "Le aule del... (…) sono sporche, i bagni maleodoranti, le veneziane a pezzi, i rubinetti perlopiù secchi, le sedie rotte, i muri ricoperti di graffiti, i cestini traboccanti di rifiuti. Che immagine dà ai ragazzi a lui affidati un preside che consente un tale degrado?". La Dirigente scolastica ha risposto sul Corriere della sera del 16 maggio, tra l’altro, in questo modo: "Quanto al giro nei gabinetti non effettuato dal Direttore generale, bisogna invece pensare che il professore ne abbia svolto uno molto accurato. Peccato non abbia chiesto piuttosto di visitare la ricchissima e prestigiosa biblioteca del liceo, oppure il suo archivio storico, o meglio ancora le raccolte scientifiche (…). Vi avrebbe scoperto dei tesori che l’avrebbero riconciliato con l’immagine ‘vera’ del…". E così Gavazzi in calce alla lettera ha potuto scrivere: "La mia critica non era agli studenti o ai professori, ma alla preside, che ha la responsabilità di far funzionare la scuola. La pulizia, un ambiente decoroso, non sono questioni di ‘immagine’. A che cosa educa una preside che, per pigrizia o per quieto vivere, accetta che chi è pagato per pulire la scuola non lo faccia?". Non capisco perché ad una domanda precisa si sia risposto con argomentazioni che non c’entrano. La domanda era: "perché è tutto sporco?". La risposta è stata: "abbiamo una bella biblioteca". Finché la scuola comunica in questo modo penso ci sia poco da fare per tirarsi fuori dalle secche in cui è caduta. Anche perché qui si nota tutta la prosopopea di chi si ritiene al riparo da qualsiasi critica perché forte di un’autorevolezza non scalfibile. §§§§§ Alcuni alunni di scuole superiori della Provincia di Udine sono stati arrestati perché spacciavano nelle scuole. I giornali locali hanno dato ampio risalto alla cosa. I Docenti e il Dirigente di un Liceo hanno inviato alla stampa una lettera simile a quella citata sopra. La domanda riguardava la droga a scuola e la risposta parlava d’altro: "Ci domandiamo, quindi: dov’è, sulle pagine degli stessi giornali, il lavoro che facciamo da anni sulla prevenzione delle dipendenze (stupefacenti, alcol, fumo) in collaborazione con l ’Azienda Sanitaria Locale, con la Provincia, con il CONI e con altri esperti? Dov’è, sulle pagine degli stessi giornali, il lavoro quotidiano(…)? Dov’è, sulle pagine degli stessi giornali, la sollecitudine spesa dai consigli di classe e dai coordinatori di progetto nel vagliare e soppesare il disagio dei ragazzi per riuscire a riconoscere, qualora si verifichino, i primi segni di disordine alimentare, di depressione patologica, di aggressività non più riconducibili a un’ età di ‘passaggio’ quale è l’adolescenza? Dove sono, sulle pagine degli stessi giornali, le testimonianze e la cronaca di allenamenti, di fatiche, di speranze, di vittorie? La cura implicita nel mestiere del docente, l’attenzione ai progressi d’apprendimento, la verifica di tali processi, la strategia innovativa per ottenerli, non fanno notizia, anzi, oltre a non fare notizia, non sono più considerati valori preziosi né dal territorio, né dai media e – attenzione perché ciò che scriviamo adesso è gravissimo – né dalla maggioranza delle famiglie". Anche in questo caso non si risponde alla domanda, né si precisa che cosa la scuola fa per prevenire un grave problema sociale, ma si parla d’altro. §§§§§ Ci sono delle normali procedure giornalistiche che aiutano a capire dove sta il problema. Bisogna sempre stare attenti a non dare una notizia negativa due volte o, come nel primo caso, a "prenderle di santa ragione due volte". Ma bisogna anche stare attenti ad essere concisi e rispondere precisamente alle contestazioni. Se una modella anoressica e alcolizzata che si fa di crack porta i figli a scuola in macchina guidando a 150 all’ora questa è una notizia, se invece una modella corretta nell’alimentazione e che beve succhi di frutta porta i figli a scuola rispettando i limiti di velocità fa molto poca notizia. Tant’è che le modelle quando vengono beccate disfatte da droga e alcol si ricoverano in clinica e questo non perché vogliano smettere di drogarsi o di bere ma perché rispondono alla domanda che viene loro fatta: cosa fai per non portare più i figli a scuola da sballata? La comunicazione è una cosa seria e i Dirigenti scolastici, che sono titolari di quella della scuola, devono imparare come si fa, senza improvvisare e senza scrivere stupidaggini sui giornali che poi gli si rivolgono contro. Queste le risposte che avrei dato io:
|