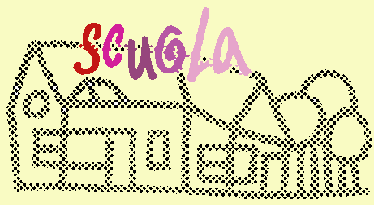 |
Direzione didattica di Pavone Canavese |
19.01.2002
TemaParagrafo uno: "la descrizione".
Se per politica s’intende qualcosa di vicino a quei programmi che un tempo si chiamavano tribune politiche o elettorali (ora salottini in finta pelle con diva, tipo Porta a porta), allora l’educazione alla politica nella scuola vive lo stesso disastro (sacrosanto, penso) della fruizione popolare – ma forse più che di popolo qui si dovrebbe parlare di moderna plebe, meraviglioso pubblico che ci segue da casa, eccetera.
Forse gli adolescenti che ho di fronte ci mettono di loro una sana noia che li fa appartenere meno al gioco televisivo di chi vince o perde – chi sorride meglio, chi è più accattivante… Ma insomma qui si alimenta quella che chiamano la loro "apoliticità", delle occupazioni perfino.
Comunque se ragazzi e ragazze chiedono di sapere della destra e della sinistra e magari cominciano a discutere, tornano ad emergere parole semplici, e certo ingenue, che in fondo però mi sembrano capaci di orizzontare: stare dalla parte dei poveri o dei ricchi; combattere contro l’ingiustizia o accettarla come normale del mondo; sentire le sofferenze degli immigrati o il pericolo della diversità. Come in una discussione sulla pena di morte, con una ragazza che dice che non si può uccidere. Non si uccide e basta. Semplice.
Anche le forme tradizionali della "rappresentanza" alle quali la scuola forse vorrebbe educare, sono spesso una specie di tragedia: assemblee assurde in attesa che i "capi d’istituto" finiscano di parlare e diano il via libera; elezioni di rappresentanti alle quali si candidano quasi solo maschietti e li votano quasi tutte ragazze, perché le luci della ribalta sono per la vanità dei belli (potrebbe essere una specie di vendetta femminile questa scelta di "valletti" per il varietà politico istituzionale – triste però mi sembra).
Ma le occupazioni "apolitiche" sono in realtà operazioni spaziali : a seconda dei punti di vista, zone liberate dalla routine della macchina buropedagogica, microfisica scolastica del potere - oppure puro vuoto di qualunque discorso culturale politico rivendicativo, solo tempo che passa… È difficile dire que pasa in questo tempo e spazio liberato-svuotato. Bisogni di identità difficili da decifrare per noi membri di un’altra tribù. Forse anche più il bisogno di essere ascoltati, di esistere come corpo collettivo – andare tutti alla manifestazione, col treno, nella grande città, esserci e sentirsi – piuttosto che avere qualcosa di ben organizzato da dire. (Quest’anno, tuttavia, nella mia scuola, di fronte a una cosa strana come "la finanziaria", il tema dello spazio ha trovato una sorprendente definizione come bisogno di luogo pubblico, aperto e non colonizzante; per la prima volta il volantino scritto da una ragazza di quarta - non capo d’istituto, cioè rappresentante nel consiglio - parlava della scuola come luogo d’incontro delle diversità, compresa quella legata alla sessualità, eterosessuale o omosessuale. È stato quasi un colpo di scena, secondo me, e i sorrisi ironici che circolavano nell’assemblea non mi è sembrato che lo svuotassero del tutto).
Paragrafo due: "l’analisi".
Qui il compito si fa difficile, perché bisognerebbe evitare i discorsini soliti che si fanno nei bar o sulle prime pagine della grande stampa italiana.
La prima cosa che mi viene in mente è l’emozione strana che ho provato qualche anno fa ascoltando la splendida raccolta delle canzoni di lotta curata dal De Martino di Ivan Della Mea. Bellissima, piena di storia e di vita, di speranze e ideali. Mi ha messo anche un po’ in crisi però. Intanto sembrava tutto appartenere a qualche millennio fa – forse è necessariamente così quando un secolo scompare da un anno a un altro come il novecento… E poi tante parole intessute di certezze assolute, attese millenaristiche (il linguaggio dell’epica forse, del sole dell’avvenire). Anche violenza: quasi una dimensione militare della politica, con il dovere morale di vincere nella guerra all’ingiustizia che non ammette dubbi o tradimenti. Insomma nel bene e nel male un’altra storia, delle grandi narrazioni, degli schieramenti netti e definitivi. Ancora negli anni settanta si cresceva con queste passioni intorno, mi sembra. Ti davano senso, memoria, progetto, speranze. Ecco, ragazze e ragazzi di oggi chiaro che non hanno d’intorno un mondo così. Gli manca la linea verticale del passato che continua nel progetto del futuro. Socialismo comunismo società senza classi fine dello sfruttamento dell’uomo sull’uomo… come essere nell’ora di religione.
Ricordo mio zio vecchio comunista-comunista (quelli che ci contestano da sinistra sono tutti traditori pagati dai padroni), quando qualche anno fa sfogliava la sua collezione rilegata - già incredibile per me – del Calendario del popolo, poteva concludere che delle speranze della sua vita non si era realizzato assolutamente nulla. Due anni dopo avrebbe vinto il primo Berlusconi. Un altro testamento del secolo Gli adolescenti di oggi non avranno la fortuna di vivere una disperazione del genere, credo.
In un certo senso vivono immersi in un presente assoluto quanto precario.
I "disubbidienti" dei centri sociali sembrano portatori di un altro bisogno di epica, quasi una forma di romanticismo esistenziale: una specie di slancio vitale, il sentirsi intensamente gruppo, con un capo carismatico e in gioco per intero direttamente con i propri corpi – sui quali portare scritto il loro discorso in gommapiuma - che sfidano le linee rosse, oltrepassano, si ribellano. Qui e ora. La teoria politica sembra passare dalla forma del ragionamento lineare, generatore di scelte, a una costellazione di idee, proposte, pratiche, generate da bisogni desideri rabbie sdegni, tipo l’ I care di Barbiana. Dove non si rivendica niente per sé, se non la possibilità costruire altro per tutti e tutte altrove.
Forse il bisogno "adulto" di sintesi (come di "coordinamento nazionale" del movimento - vedi il dopo Genova dei social forum) deve accettare di appartenere a un’altra generazione. Forse oggi esiste più una rete di desideri, sintesi al massimo come comune geografia di luoghi in cui incontrarsi e dirsi, che il bisogno di linee che dettino obiettivi o piattaforme.
Paragrafo tre: "il commento personale".
Qui, a questo punto, sono sempre entrato in crisi.
Cosa vorrà che si scriva la professoressa? Chissà se se lo chiedono anche i miei
studenti…
Potrei copiare la tecnica compositiva di molti loro, di quelli che cominciano sempre con fin
dai tempi della preistoria l’uomo e concludono con io spero che in futuro il
mondo…. Ho scoperto che va bene per un sacco di roba effettivamente.
Però non saprei dire tanto bene che vorrei io per il futuro.
Il rischio che sento è oscillare, magari cercando un equilibrio, fra apocalittici e
entusiasti: fra quelli che vedono nei giovani tutto il disastro di una generazione senza
padri (così si dà una botta anche a quelli del sessantotto), valori superiori, senso del
dovere e non solo dei diritti – figli di un consumismo ipercapitalistico modello
Lucignolo nel paese dei balocchi (nella scuola sarebbe la cultura del tutto facile,
promozioni d’ufficio, nessuna fatica nessuna selezione); e quegli altri che nella
politica dei desideri e nella gratuità del piacere vedono la possibilità di un altro
antagonismo, meno sacrificale e tuttavia capace – pure nell’orizzontalità di
una fratellanza senza gerarchie guida – di produrre un altro senso della vita,
un’altra idea di autorità (non patriarcale) e di felicità, non privatistica o di
consumo ma politica, attraversata dalle sofferenze del mondo, costruita nelle relazioni.
L’equilibrio è difficile (e troppo facile la tentazione).
Io posso concludere sperando per il futuro che il capitalismo produca i suoi figli
degeneri, dal consumismo sovversivo col senso ironico del limite (che potrebbero allearsi
con le donne, come ha scritto Maria Luisa Boccia, di un altro genere pure loro). E
il loro futuro perdere la forza antica del progetto compiuto – peraltro segnata dalla
rigidità di organizzazioni, gerarchie, finalismi – per acquistare la leggerezza dei
messaggi che arrivano ogni tanto nel monitor con estensione chiocciola inventati punto
org (dove org forse sta per orgasmo).