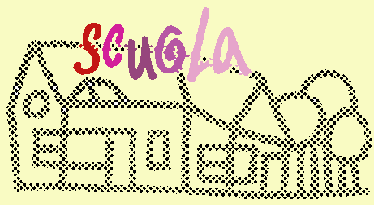 |
Direzione didattica di Pavone Canavese |
15.11.2002
A proposito di Pinocchio:
C’è un aspetto un po’ imbarazzante
per un insegnante nel fare i conti con Pinocchio. Ci si sente grilli,
insopportabilmente dalla parte della ragione (e per di più protetti dalle comode mura
dell’istituzione, a differenza del grillo famoso, in fondo maestro di strada).
Io poi ho il ricordo di quando con mio fratello – un capitolo per uno –leggevamo Le avventure di Pinocchio alla mia nonna. Per molti sarà stato il contrario, ma mia nonna era analfabeta (per quanto grande appassionata del maestro Manzi di Non è mai troppo tardi) e ci dava un gran piacere leggerle i libri. Era la nostra piccola grandezza.
Però a me faceva paura leggere Pinocchio. Era come sentire la voce del parroco del paese. Il mondo era inesorabilmente diviso in male e bene, e ci si salvava dalla colpa solo dopo averne pagato il prezzo. Non s’imparava mai qualcosa senza una qualche pena. Una "lezione" appunto.
La mutazione fisica in asino – prima le orecchie, poi la coda, poi la voce: una progressione nella perdita di sé, nell’essere posseduti, irriconoscibili a se stessi – io la ricordo come una delle esperienze di lettura più angosciose mai vissute. Un horror (peraltro come l’idea di svegliarsi e scoprire i propri piedi bruciati al fuoco del camino - nella propria casa addirittura, luogo della sicurezza). Ma le grandi storie sono tutte un po’ d’orrore.
Quando ho riletto Collodi "da grande", mi ha colpito un’altra durezza: la secca meccanica delle emozioni, come una giostra amara di desideri negati, on the road di ripetizioni, sincere recidive menzogne, occasioni mancate. Asciutto antieroico percorso d’iniziazione. Senza sentimentalismi – dunque con sentimenti che arrivano netti e potentissimi.
Poi (colpo di scena) da grande finisce che fai proprio il maestro.
Stai cioè dalla parte di quelli che insegnano (magari senza lasciare segni), sanno il bene e il male, come andranno le cose se. Quelli sempre inchiodati al Libro, e che inchiodano alle responsabilità verso i Padri e le loro giacchette.
Insomma ci si sente come se si fosse passati dall’altra parte: te l’avevo detto io, chi non ubbidisce (non studia, non fatica, non si sacrifica) finisce in prigione o all’ospedale. Educatori parlanti grilli. Altro che Don Milani e la sua disubbidienza. Quelli che mentre "formano" e fanno nascere il ragazzo perbene, cittadino modello, intanto regolamentano spengono uccidono il burattino. E il tema della morte mi sembra essere il cuore oscuro del film di Benigni, la sottile linea rossa che lo attraversa al fondo. È anche un bizzarro paradosso che la nascita di un corpo disciplinato passi attraverso il lasciar morire su una sedia qualunque, disarticolato cioè disanimato, un libero burattino: non-corpo anarchico insurrezionalista, come direbbe il ministro Pisanu. Come fosse il prezzo che la nuda vita paga per essere riconosciuta umana.
Meno male che Benigni e Cerami ci lasciano alla fine correre con l’ombra del burattino, a inseguire una farfalla - e allora si torna all’inizio, non è successo nulla in fondo, un folle tronco di strano legno sempre di nuovo si ribellerà ai gendarmi. Ci sono più cose fra la terra e il cielo, eccetera.
Però, da insegnante proprio, quello che mi piacerebbe saper fare è l’elogio di Lucignolo. Anima grande. Vagamente "underground".
Sopra il film è una lussuosa e sgargiante, insolita per il cinema italiano, illustrazione della "fiaba" (vestiti da Barbie-Principessa, carrozze e cocchieri luccicanti di topini, cittadine da colazione Mulino Bianco), ma sotto manda segnali inquietanti una corrente dark in controtendenza: sofferenza, pianto, desideri di morte. Posso morire? Ma come si fa a morire…Già suo fratello è morto (e muore la bambina-dai-capelli-turchini, fata sorella che non c’è nel film, sostituita da una specie di zia). Ma non può morire Pinocchio, può solo crescere e quella è la sua morte.
Ecco, nella grammatica profonda del film, scorre Lucignolo, il non domato, e non domabile. Fino alla fine il grande amico – anche quando Pinocchio, ormai bravo ragazzo, lavoratore, aiuto del padre, lo dovrebbe considerare il Male, la tentazione tante volte conosciuta della devianza, il principio "orrendo" del piacere. Invece piange per lui e gli offre l’ultimo lecca-lecca (al mandarino, il migliore, anzi la fine del mondo). Pinocchio se lo concederà ormai solo per cena, mediazione accettabile: tre leccate una sera da una parte, tre il giorno successivo dall’altra (ma per fortuna, di nascosto al padre, una piccola quarta leccatina mi pare la dia…).
Lucignolo resiste. Muore di sfruttamento, come un extracomunitario qualunque della Bossi-Fini, ma libero dentro. Capace di ironia. Quasi una vendetta dell’asino di Rosso Malpelo, nello stesso mondo naturale d’ingiustizia.
Certo è un po’ l’anti-scuola. Seguace di Illich e Foucault, direbbero certi miei amici (anch’io frequento cattive compagnie: le migliori, la fine del mondo). Il desiderio contro l’ordine, il presente in luogo del futuro, il movimento contro il disciplinamento. Ma gli adulti carcerieri non sono solo nella scuola – dove il maestro ha già deciso di bocciarlo, magari per salvare i Pierini dell’epoca: il Paese dei Balocchi è l’ingresso postmoderno di un’industria, formazione professionale all’americana per consumatori-lavoratori ideali; e il lavoro (se non vuoi andare a scuola, allora trovati un onesto lavoro, Collodi non immaginava percorsi integrati, raddoppio della pena) è sempre lavoro da ciuchi, tirare la carretta, girare ai ritmi della catena. Non c’è toyotismo possibile nei bassi fondi delle fiabe sgargianti. Tutta la società è un’istituzione totale. Per questo forse, alla sua festa di promozione (e che promozione: da inorganico a umano, senza nemmeno "passerelle") Pinocchio parte alla ricerca della sua Grande Anima. Lo vuole con sé il suo peggiore compagno di banco, così vicino così lontano. Non lo lascia perdere.
Mi viene da pensare che questa potrebbe essere la mia personale "riforma della scuola". Magari il ministro Moratti, la fata furbina, lo chiamerebbe Progetto Lucignolo (e l’affiderebbe a S.Patrignano). Ma dovrebbe essere una specie di ossimoro: mettere al centro l’Irrecuperabile, e proprio come epistemologia, tutt’altro che separazione dei percorsi (per addestrare alcuni alla "dignità" di un lavoro da servi, altri alla responsabilità della classe dirigente; lasciamolo dire ai padroni del circo e ai loro zelanti intellettuali dalle orecchie nascoste sotto i cappelli). Bisognerebbe ripartire dall’impegno antico, e non pietistico, del non uno di meno, per riportarli nelle nostre classi (non in altre apposite) i Lucignoli, dico. E portare dentro, fra i banchi di nebbia buro-pedagogica, i loro desideri indomabili. Qualche ombra anche, che liberi qualche corpo. Come farfalla.
Oggi possiamo anche riconoscere, e perfino amare, la pedagogia ribelle del Mahatma Lucignolo: non c’è intelligenza senza emozioni, non c’è apprendimento senza desiderio. Non c’è scuola senza un po’ di libertà e di vita.