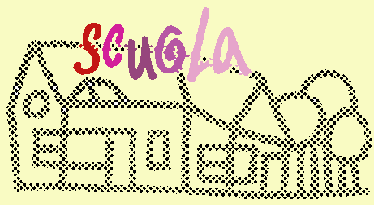 |
PavoneRisorse |
|
altre sezioni LABORATORIO STORIA 900 |EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA |
“La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione” G. Gaber
(18.05.2013)
Pensi come parli!
Le modificazioni del linguaggio portano a
modificazioni del modo di pensare e di agire
di Rodolfo Marchisio
Come leggere il web. Ipertesto e multimedialità
Abbiamo visto nella tappa
precedente come le TIC modifichino il nostro modo di scrivere.
Intanto quel pezzo conteneva già note a piè pagina, immagini e collegamenti
ipertestuali.
Mentre le immagini hanno sempre accompagnato la scrittura, prima ancora della
stampa, e i monaci medievali annotavano i libri a fianco e in ogni spazio
possibile, una novità sembra essere il collegamento ipertestuale (ad
altri testi).
Se da un lato la possibilità di saltare da un libro all’altro esisteva già prima
– i monaci avevano pedane per leggere e scrivere, rotonde e che potevano girare,
per passare da un documento all’altro– è indubbio che l’ipertestualità e
la ipermedialità sono caratteristiche fortemente legate alle attuali
tecnologie della scrittura e lettura. La possibilità di saltare con un
collegamento da una pagina o da un sito a un altro consente di rendere la
lettura non più lineare, sequenziale, gerarchica, ma ipertestuale, più simile a
un saltellare o navigare a vista seguendo link che contengono inviti
operativi: bottoni che ci “chiedono” di essere cliccati.
Da qui la metafora del “navigare in rete”.
Non c’è nessun ambiente, sito, SN in
rete che non sia multimediale – che non faccia cioè convivere parole,
immagini, suoni, filmati etc…- e che non contenga molti link –
collegamenti – talora utili, talora pericolosi (pubblicità o siti a pagamento).
L’attuale format di FB riserva 1/3 dello spazio a notizie anche riservate e
impiccione su di noi, 1/3 per la nostra pagina o diario, 1/3 per pubblicità. In
tutto abbiamo meno del 25% del monitor per esprimerci. E’ il costo di una
rete che sembra gratuita, ma che vive di pubblicità o di furti d’informazioni su
chi la usa. Ho già citato il
caso recente di un Italiano che, vinta la causa, si è fatto restituire da FB
850 pagine d’informazioni raccolte su di lui.
Lettura
ipertestuale e multimediale.
La presenza d’immagini, suoni, filmati, rende la lettura più coinvolgente e ricca se è fatta in modo complementare (l’immagine completa il testo e aggiunge informazioni) e non è solo, come in alcuni libri di testo, un abbellimento.
La possibilità di saltare da un testo o documento ad un altro permette diversi tipi di lettura: navigazione secondo uno scopo, esplorazione, navigazione a vista, casuale, fino a diventare un gioco, un cazzeggiare divertente, ma inutile.
Anche la lettura può diventare, come la
scrittura, sociale, condivisa: alcuni
ambienti permettono di “discutere singoli passi, condividere note e
osservazioni, saperne di più su personaggi e luoghi” cfr Wired n 6/12 p 28. I
lettori possono portare idee e contributi nuovi.
D’altra parte da Dickens a Collodi molti scrivevano a puntate per vedere la
reazione dei lettori e da tempo si scrive a 4 o 6 mani, passandosi un testo fra
autori diversi che ci lavorano.
Il concetto
d’ipertesto nella rete e nell’apprendimento.
Il concetto d’ipertesto è uno dei più innovativi portati dalla rete, tanto
che Internet stesso è stato definito “il modello dell’ipertesto universale”,
con la sua rete di Pc non gerarchica.
Anche se Internet, come ricorda anche R. Luna, non è una rete di Pc, ma una
rete di persone, di relazioni fra persone, soprattutto. Su questo
vale la pena insistere sempre.
Alcuni pedagogisti si sono spinti ad affermare che con un ipertesto
multimediale (sito, testo, ambiente) noi impariamo meglio e più in fretta
per due motivi:
L’interazione di più linguaggi, soprattutto immagini e video, aumenta l’apprendimento e le cose rimangono più a lungo nella memoria, come noto.
Ma soprattutto perché l’ipertesto imita il modo di funzionare del nostro cervello quando apprende, sia dal punto di vista funzionale (saltare da un’idea a un’altra, creando collegamenti) sia dal punto di vista fisico (le informazioni saltano da una cellula all’altra del nostro cervello, attraverso le sinapsi)
La teoria dell’isomorfismo (costruire uno strumento di apprendimento che
imiti il modo di funzionare del nostro cervello) è in buona parte vera: il
nostro cervello raramente procede in modo sequenziale, ordinato, gerarchico o
deduttivo come un libro.
Anche se nelle scuola è stata usata pochissimo e fuori molto di più.
Autori e
proprietari. La condivisione.
La rete con il suo ideale iniziale di condivisione e
collaborazione ha portato anche a ragionare in modo diverso sui diritti di chi
scrive, i diritti d’autore.
Accanto al Copyright (proprietà dell’autore del prodotto, anche a
fini commerciali) è comparso l’open source nella programmazione,
cioè programmi gratuiti, disponibili gratuitamente per tutti (ad es: Open
Office, Modzilla etc…sino alle App per i cellulari), ma anche
aperti alle modifiche che altri vorranno fare.
Nella scrittura, il copyleft, prodotti a disposizione di tutti.
Si è anche studiato il diritto d’autore, definendo una serie di contratti fra
chi produce e chi legge o prende: le licenze Creative Commons.
Sono sei tipi di bollino che possiamo applicare alle foto o ai testi che
pubblichiamo, che possono essere prese da altri, ma ad es. a condizione che
venga citato l’autore oppure prese e modificate, ma non a scopo di lucro, per
guadagnarci. Sono 6 diversi modi di condividere con altri quello che
produciamo. Cfr Wired n 12/12 p 40
Sono ca 500 milioni le opere che girano così in rete di cui 230 milioni di foto
e il 10% degli articoli scientifici. Ci sono poi programmi apposta per
condividere come Istagram per le foto.
Come le modificazioni del linguaggio ci portano a modificare il modo di pensare
Abbiamo già parlato del
linguaggio delle TIC e delle sue
caratteristiche e di come influenza il linguaggio corrente. Ma ci sono
modificazioni più pesanti.
Nei temi dei nostri ragazzi, alla TV, in rete osserviamo:
Il punto rilevante è che
le semplificazioni del linguaggio portano a una semplificazione
eccessiva del pensiero, del nostro modo di ragionare: si motiva,
spiega, articola, subordina sempre meno e si afferma senza dimostrare.
Stiamo passando dal linguaggio complesso a quello troppo semplificato, ma
anche dal pensiero complesso al pensiero semplice. Le cose non sembrano
mai complesse e chiunque con poche affermazioni può dire la sua senza
spiegare; in TV, in rete abbondano le chiacchiere da bar fatte di brevi
quanto perentorie osservazioni per risolvere problemi complessi: tutti sono
in grado di governare e di fare la nazionale di calcio.
Le TIC aumentano la nostra
possibilità di comunicare, il numero dei nostri rapporti e dei nostri messaggi:
scriviamo molto di più, abbiamo relazioni con più
persone, ma in modo diverso, talora
semplificato e questo è comunque positivo, ma l’obiettivo è sempre quello di
imparare ad usare diversi linguaggi in diversi contesti.
Es: Proviamo a scrivere un messaggio nei 140 caratteri (spazi e punteggiatura
compresi) di Twitter, ma spiegando cosa diciamo e perché.
Il congiuntivo e il condizionale come
modi del dialogo, della relatività, del rispetto.
Se esistono i modi del
verbo è perché hanno una utilità. Usare una subordinazione – se….allora –
usare un periodo ipotetico, significa subordinare un’azione o affermazione al
verificarsi di una condizione, usare il congiuntivo significa esprimere una cosa
possibile, eventuale, non sicura. Per questo usare l’indicativo sempre
significa, anche inconsapevolmente, esprimere certezza, non sottoporre le
nostre affermazioni al verificarsi di condizioni; usare il congiuntivo o il
condizionale significa anche presentare un’affermazione come possibile, ma come
discutibile, dimostrarsi aperti al dialogo, al rispetto
dell’opinione dell’altro, sottolineare anche con connettivi (congiunzioni o
altro) che non siamo sicuri o che comunque siamo disponibili a discuterne.
Che ciò che affermiamo ha un valore relativo e non assoluto e che le cose
sono complicate e non semplici.
L’educazione linguistica fa parte della formazione del cittadino e quindi della
democrazia.
Per due motivi:
1- Chi sa più parole ha più forza, spesso vince. Don Milani scriveva coi suoi ragazzi: il padrone sa mille parole, l’operaio 100. Per questo vince il padrone.
2- Le competenze linguistiche – oggi anche quelle della parola elettronica – sono competenze di cittadinanza essenziali.
Competenze
linguistiche, competenze TIC e competenze di cittadinanza.
Le competenze di cittadinanza sono
competenze chiave e viceversa. Le competenze linguistiche sono alla base delle
competenze di cittadinanza oltre che delle competenze chiave.
Né un analfabeta
informatico, né un analfabeta sono veri cittadini.
Va, comunque, ricordato che non soltanto le competenze civiche e sociali sono
“competenze chiave”, ma anche che tutte le competenze chiave possono essere
considerate competenze di cittadinanza perché sono tutte necessarie alla
partecipazione attiva e consapevole dei cittadini alla vita sociale,
lavorativa, politica (B.
Losito).