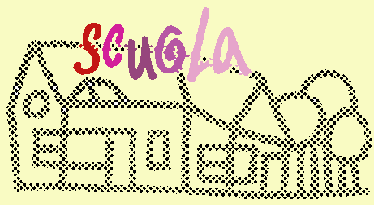CATARSI, Enzo Storia dei programmi della scuola
elementare (1860 – 1985)
Firenze, La Nuova Italia, 1990
Il volume documenta e analizza i contenuti e il significato dei
programmi della scuola elementare dall’Unità d’Italia ad oggi, evidenziando il
legame che unisce scuola e società.
L’autore condivide la tesi di D. Bertoni Jovine, secondo la quale
a determinare i programmi di insegnamento non sono soltanto le teorie e pedagogiche e
didattiche, ma concorrono in maniera decisiva la situazione politica, gli ordinamenti
sociali, la struttura statale, i rapporti di convivenza, ed è quindi attento a rilevare,
dietro ogni scelta pedagogica, i nodi che rendono riconoscibile l’ideologia ad essi
sottesa.
La figura del maestro, il libro di testo, la maggiore o minore
importanza attribuita all’insegnamento religioso, il problema della lingua italiana,
la stessa gerarchia delle discipline di studio, sono i nodi sui quali viene focalizzata
l’attenzione anche al fine di rimarcare la predominanza, in alcune situazioni, della
teoria pedagogica, in altre, del quadro politico.
Emerge da questa storia dei programmi, e l’autore ne è più che
consapevole, un quadro della scuola "legale" che raramente ha coinciso con la
scuola reale dove i cambiamenti percorrono, nel bene e nel male, tempi e culture
professionali diverse.
La prima parte del libro contiene l’analisi vera e propria dei
diversi Programmi; già dai titoli dei capitoli ad essi dedicati emerge il pensiero che ne
è ispiratore.
- I programmi dell’unificazione (1860 – 1867)
escono un anno dopo
l’introduzione dell’obbligo scolastico che la legge Casati affida ai Comuni. Gli
obiettivi politi e sociali sono evidenti: contribuire alla unificazione linguistica e
culturale dello Stato Nazionale che si era appena costituito. Si fondano
sull’insegnamento della religione, della lingua italiana, dell’aritmetica.
- I programmi del positivismo (1888):
conosciuti come programmi Gabelli pongono al
centro della loro elaborazione il problema del metodo inteso come predisposizione ad
acquisire strumenti per imparare dall’osservazione e dall’esperienza.
- I programmi del conservatorismo (1894 – 1899)
nascono ad opera della
commissione Baccelli in un clima, quello di fine ottocento, sempre meno favorevole nei
confronti dell’istruzione popolare considerata dai gruppi moderati e conservatori un
pericoloso veicolo di propagazione di idee nuove. L’obiettivo è conformisticamente
<<educativo>> e la disciplina che più ne risente è la storia il cui
insegnamento deve tendere all’educazione morale e patriottica.
- I programmi dell’età giolittiana
del1905 seguono di un anno la legge Orlando
che estende l’obbligo scolastico fino al dodicesimo anno d’età e che istituisce
un corso popolare programmaticamente separato e chiuso alla frequenza di coloro che
continueranno gli studi. Le caratteristiche della legge influenzano i programmi che
puntano alla divisione degli alunni a seconda della provenienza sociale e della loro
opportunità future. Di qui il carattere pratico, utilitaristico, immediatamente
utilizzabile dell’insegnamento elementare (soprattutto nel corso popolare).
- I programmi dell’idealismo (1923).
La riforma che prende il nome da G. Gentile,
rappresenta la legge caratterizzante la politica scolastica del nascente regime
fascista che in assenza di un proprio programma scolastico, adatta alle sue esigenze,
quello del movimento idealistico. L’istruzione elementare conserva il carattere
conservatore e d aristocratico attribuitole dal liberalismo ottocentesco.
- I programmi del fascismo (1934).
Con la progressiva trasformazione del fascismo in
regime totalitario, l’ordinamento gentiliano si rivela presto inadeguato. La
valorizzazione della libertà d’insegnamento contrasta evidentemente con
l’obiettivo di formare il "perfetto fascista". Elemento fondamentale del
processo di fascistizzazione della scuola sarà l’introduzione del libro unico di
stato. I nuovi programmi presentati come in <<continuità>> con quelli del
’23 presentano in realtà modifiche e ritocchi sostanziali per rendere la scuola uno
strumento di regime.
- I programmi della democrazia (1945).
Preparati da una commissione nominata nel
luglio ’44, si contraddistinguono per il loro carattere innovativo ed esprimono la
grande tensione morale e culturale che li anima fin dalle prime parole che indicano quale
compito primario della scuola quello di contribuire alla <<rinascita della vita
nazionale>>. I programmi prevedono un insegnamento di tipo concreto che mette i
bambini in grado di apprendere operativamente.
- I programmi dell’<<attivismo cattolico>> (1955),
firmati dal
ministro Ermini, presentano almeno dal punto di vista metodologico, molti connotati
attivistici e si rifanno ad un radicale liberalismo educativo che tende al rispetto
dell’autonomia di insegnanti e alunni. Stridente dunque il contrasto con il carattere
dogmatico dell’insegnamento religioso e con l’impronta confessionale data ai
programmi, frutto evidente di scelte politiche orientate dagli ambienti ecclesiali e dalle
forze cattoliche.
- Verso i nuovi programmi
traccia una breve sintesi dei profondi cambiamenti che hanno
segnato gli anni sessanta e settanta, le rivendicazioni sociali di quegli anni, i fermenti
culturali dei movimenti giovanili e studenteschi, l’introduzione della scuola media
unica, la marcata attenzione alla selezione scolastica, l’esperienza di Barbiana, la
scuola a tempo pieno…
Sono del ’79 i nuovi programmi della Media e a partire dagli anni
ottanta, si comincia ad auspicare una riforma della scuola elementare che veda anche il
superamento dei programmi del ’55.
La seconda parte del libro contiene il testo dei programmi, le
istruzioni ad essi collegate, i regolamenti, i consigli.
Da segnalare, nella terza parte, oltre ad una esauriente bibliografia,
il Piccolo dizionario biografico che contiene le schede relative agli
studiosi e agli uomini politici più autorevoli citati nel saggio.