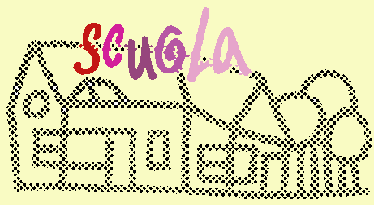 |
Direzione didattica di Pavone Canavese |
L'ispirazione
cognitivista
|
Con la denominazione "scienza cognitiva" ci si riferisce a una nuova disciplina che nacque ufficialmente negli Stati Uniti nel 1978 e che raccolse fin da allora, intorno ai problemi della natura e del funzionamento della mente, studiosi provenienti da diversi campi del sapere: filosofi della conoscenza, psicologi cognitivisti, "uomini dei calcolatori", linguisti, neuroscienziati, antropologi.
Gli scienziati che si riconoscono in questa nuova comunità ritengono che essa debba assumere sempre di più una sua forte identità e autonomizzarsi rispetto alle discipline di origine; debba cioè fare ricerca sulla mente e creare modelli esplicativi della sua natura e del suo funzionamento con uno stile del tutto peculiare.
Quando si dice che la nuova normativa della scuola elementare italiana ha una forte ispirazione cognitivista, alcuni fanno riferimento, a torto, a un periodo particolare della storia della psicologia cognitivista che va sotto il nome di Human Information Processing (HIP). Come è stato ampiamente illustrato in questo volume, si tratta della prima "era" della psicologia di impostazione cognitivista: quella che va dalla fine degli anni sessanta alla metà degli anni settanta. E il periodo in cui la psicologia sperimentale più accreditata a livello internazionale abbandona per sempre i paradigmi del comportamentismo per affrontare di petto il problema dello studio di ciò che succede all'interno della mente.
I comportamentisti dicevano che la mente è una "scatola nera" e ritenevano che su di essa sarebbe stato scorretto indagare con metodo scientifico in quanto non era possibile osservarne direttamente il funzionamento. Essi puntavano i loro riflettori sulle corrispondenze tra gli stimoli provenienti dall'esterno e i comportamenti con i quali l'organismo risponde a quegli stimoli. La configurazione dell'insieme delle diverse innumerevoli corrispondenze tra stimoli e risposte era, secondo loro, tutto quanto la psicologia poteva prefiggersi come scopo della sua ricerca. Ciò che avviene all'interno dell'organismo e che produce quelle corrispondenze era escluso dall'indagine dei comportamentisti.
Al contrario gli psicologi cognitivisti si prefissero, fin dall'inizio, proprio lo scopo di elaborare teorie relative alla natura e al funzionamento della "scatola nera" e si costruirono alcuni convincimenti di base, adeguati a quel fine. Innanzitutto assiomatizzarono l'esistenza della mente. La mente, a ben pensarci, non è sotto i nostri occhi: nessuno può dire che esista realmente. Le due realtà che sicuramente esistono sono il mondo fisico che sta intorno a noi e il cervello (anch'esso peraltro oggetto fisico) mediante il quale conosciamo il mondo. L'assumere che tra il mondo e il cervello ci sia "qualcos'altro" si configurò come un'opzione molto forte che caratterizzò in modo inequivocabile la prospettiva cognitivista.
L'entrata in funzione dei primi computer fornì agli psicologi cognitivisti degli anni sessanta lo spunto per dire che la mente sta al cervello come il software sta all'hardware di un calcolatore. La mente, essi dicevano, conosce sia il linguaggio del mondo sia il linguaggio del cervello e sa farli incontrare. Se non esistesse la mente, come ambiente di aggiustamento tra il mondo e il cervello, per l'uomo non sarebbe possibile elaborare gli input provenienti dall'esterno e produrre gli output di risposta. Per il computer vale, d'altra parte, lo stesso principio: se non ci fosse qualcosa che sapesse mettere d'accordo l'azione dell'utente con la tecnologia della macchina, non sarebbe possibile per l'uomo impiegarla per i suoi scopi.
I primi psicologi cognitivisti, convinti che la mente dell'uomo processasse le informazioni provenienti dall'esterno secondo veri e propri programmi simili a quelli di un calcolatore, elaborarono una grande quantità di micromodelli di funzionamento della mente, ognuno dei quali si riferiva a un'attività mentale molto specifica e doveva necessariamente venire tradotto in linguaggio computazionale per poter assumere dignità scientifica.
Questo modo di intendere e di studiare la mente è appunto quello che, nel dibattito educativo del nostro paese, veniva tempo fa associato al termine cognitivisrmo. I fautori di una pedagogia ispirata al cognitivismo, pertanto, furono spesso negli anni passati convinti assertori di progetti didattici fondati su modelli di funzionamento della mente molto dettagliati, poco aperti al nuovo e all'imprevisto, rigidamente mirati a obiettivi prefissati. (A dire il vero nelle loro unità didattiche "dure" c'era più comportamentismo che cognitivismo!) Viceversa chi non credeva che nell'educazione fosse possibile procedere secondo teorie rigide e con programmazioni esaustive a priori, mirate esclusivamente all'educazione intellettuale, guardava con diffidenza e spesso con avversione alle teorie che si richiamavano al cognitivismo. Tutto questo è un grande equivoco che va chiarito.
La storia del cognitivismo non si ferma al periodo dello Human Information Processing. Già nei primi anni settanta si costituì una corrente di ispirazione "ecologica" che contestava il fatto che la mente umana potesse essere assimilata a un computer e riteneva che non avesse senso parlare di elaborazione delle informazioni. Gli psicologi ecologisti asserivano che tra l'uomo e l'ambiente si instaura un rapporto "diretto", non mediato da interfacce e programmi computazionali; e soprattutto non accettavano il fatto che la ricerca psicologica producesse grandi quantità di micromodelli, tutti diversi tra di loro, non riuscendo così più a rendere ragione dell'unicità della mente e del suo funzionamento.
Dopo qualche anno di contrapposizione teorica e operazionale tra le due anime della psicologia cognitivista, prese piede, verso la fine degli anni settanta, la "scienza cognitiva". Mentre prima di allora era la psicologia sperimentale a ispirazione cognitivista a dominare la scena, malgrado i molti debiti che andava via via contraendo specialmente con la scienza dei calcolatori e con le neuroscienze, la nuova comunità scientifica intraprese con determinazione la strada di una forte integrazione tra le diverse discipline che abbiamo prima citato e si predispose alla creazione di un modo nuovo e più completo di modellizzare il funzionamento della mente.
Ovviamente l'assioma mentalista rimase, ma fu il concetto di rappresentazione delle conoscenze, guidata da scopi-intenzioni-decisioni, a costituire il vero nucleo unificante della nuova prospettiva. Howard Gardner afferma:
Optando per il livello della rappresentazione, lo scienziato cognitivo sostiene che certi modi tradizionali di spiegare il pensiero umano sono inadeguati. Il neuroscienziato può decidere di parlare nei termini di cellule nervose, lo storico o l'antropologo nei termini di influenze culturali, la persona comune o il romanziere nei termini del livello esperienziale e fenomenologico. Pur non contestando l'utilità che questi livelli possono avere per vari scopi, lo scienziato cognitivo fonda la sua disciplina sull'assunto che, a fini scientifici, l'attività cognitiva umana debba essere descritta nei termini di simboli, di schemi, di immagini, di idee e di altre forme di rappresentazione mentale
Non appena la nuova comunità scientifica si consolidò, emerse quella contrapposizione tra l'orientamento connessionista e l'orientamento modularista che ancora oggi monopolizza il dibattito e che alcuni degli autori di questo libro considerano, come abbiamo visto, in gran parte oziosa e necessitante di una rapida ricomposizione.
I modularisti ritengono, pur con molte sfumature diverse al loro interno, che sia un errore considerare la mente come un tutto unico che si mobilita in blocco ogniqualvolta abbia bisogno di elaborare informazioni e produrre rappresentazioni delle conoscenze. Se la mente operasse in modo globale, dicono i modularisti, non si spiegherebbero né la velocità di reazione agli stimoli esterni (come ritiene il filosofo Fodor) né la differenza di stile cognitivo a seconda dei contenuti della rappresentazione (come dice lo psicologo Gardner).
I connessionisti rifiutano l'ipotesi che la mente funzioni per moduli (Fodor) o per intelligenze multiple (Gardner), e la immaginano come una rete straordinariamente interconnessa e plastica. Ritorneremo sul dibattito tra modularisti e connessionisti nell'ultima parte di questo capitolo.
Va ancora detto che il computer continuò a restare al centro dell'attenzione della nuova comunità scientifica sia come strumento per l'indagine sia come metafora di funzionamento della mente. Tuttavia, come dice Gardner,
l'applicazione rigorosa di metodi e di modelli tratti dall'ambito del computer ha aiutato gli scienziati a comprendere gli aspetti sotto cui gli esseri umani non sono affatto simili a tali computer prototipi.
Non intendo dire con questo che nessun processo cognitivo si approssimi al funzionamento di un computer: alcuni, anzi, sono molto simili al suo modo di elaborazione (...) Voglio dire piuttosto che il tipo di visione sistematica, logica, razionale della cognizione umana che pervase le prime pubblicazioni sulla scienza cognitiva non descrive in modo adeguato molta parte del pensiero e del comportamento umani
Gardner parla a questo proposito di un "paradosso computazionale" che suona più o meno così: è stato proprio l'uso, peraltro preziosissimo, che si è fatto del computer per creare modelli funzionali della mente umana a dimostrare quanto la mente sia diversa da un computer. Ma c'è da aggiungere che negli ultimi anni il paradosso ha agito anche in senso inverso; infatti è avvenuta una vera e propria rivoluzione nel campo della scienza dei calcolatori proprio in quanto si è cercato di costruire una nuova macchina che si avvicinasse il più possibile a quello che, con tutta probabilità, è il modo di funzionare del cervello e della mente umana.
L'aver constatato la fondamentale differenza tra la mente umana e il calcolatore non ha quindi prodotto l'abbandono della metafora computazionale ma, al contrario, ha stimolato a proseguire nella sfida inizialmente lanciata. I calcolatori che hanno prodotto il paradosso di cui parla Gardner erano calcolatori di quarta generazione (del tipo dei nostri PC domestici) che elaboravano le informazioni serialmente e cioè in modo lineare all'interno di un canale unico. E piuttosto ovvio che non potessero simulare in modo credibile certi processi complessi della mente umana. Oggi però sono operanti i calcolatori di quinta generazione (e già se ne prospettano di sesta, settima...) che mettono in parallelo una grandissima quantità di calcolatori seriali. I percorsi dell'elaborazione dell'informazione allora non sono più lineari e a senso unico, ma permettono enormi quantità di combinazioni diverse e di autoregolazioni, proprio come succede all'interno del nostro cervello e della nostra mente.
Quanto detto a proposito del calcolatore dimostra in modo piuttosto chiaro come sia stato importante integrare diverse discipline all'interno della stessa comunità scientifica. Possiamo dire, a un livello molto generale e facendoci aiutare da Gardner, che nella nuova scienza della mente:
la filosofia "fornisce molti fra i problemi che devono essere investigati, (...) esamina le risposte che vengono fornite, aiuta ad interpretarle e a integrarle, e fornisce critiche dell'intera impresa"
la psicologia cognitiva sperimentale e l'intelligenza artificiale (IA) intrecciano legami sempre più stretti: "Gli psicologi possono beneficiare delle accurate simulazioni compiute dai cultori dell'lA, e possono sottoporre a test rigorosi i loro modelli normalmente informali; gli scienziati dell'IA possono verificare se i loro presunti modelli del comportamento umano siano realmente realizzati dai soggetti su cui essi hanno speculato"
la linguistica "offre una spiegazione dell'abilità più importante nell'armamentario cognitivo umano" e mette a disposizione il "terreno migliore per la verifica di una teoria cognitiva integrata"
le neuroscienze costruiscono "ponti esplicativi fra il livello dei neuroni e il livello della regola e del concetto"
l'antropologia aiuta a capire il "fatto che, in ultima analisi, tutti i risultati che possono essere conseguiti da un qualsiasi individuo in una qualsiasi cultura sono limitati dai particolari caratteri della nostra specie e, più specificamente, del sistema nervoso che possediamo in virtù della nostra appartenenza al genere umano"
Per ulteriormente evidenziare l'utilità dell'integrazione disciplinare all'interno della scienza della mente, Gardner, polemizzando con quei neuroscienziati che ritengono di non aver alcun bisogno di altre discipline per descrivere il funzionamento della cognizione, avanza argomenti quanto mai suggestivi:
Non è possibile studiare la percezione - neppure le sue forme a grana più fine - senza una teoria della percezione. Non è possibile studiare la classificazione senza avere una teoria della categorizzazione, senza una concreta conoscenza dei campi che devono essere categorizzati, e senza una comprensione dei problemi filosofici implicati nella costruzione o nell'uso di una categoria (...) Non è possibile entrare nel sistema nervoso come osservatori interessati che stiano facendo semplicemente una cronaca dei fatti (come ritengono di fare molti neuroscienziati). Tanto gli argomenti studiati quanto i modi in cui essi sono studiati rifletteranno teorie implicite: teorie sulla natura della percezione, della cognizione o del linguaggio; su ciò che c'è di importante in ciascuno di questi processi; e su come ciascuno di essi abbia luogo (...) Così, per fare un esempio tratto dal linguaggio, un neurologo ignorante della linguistica potrebbe fondarsi su intuizioni ingenue sul linguaggio, descrivendo per esempio un paziente afasico come una persona incapace di usare "parole brevi" o di "esprimersi con frasi compiute". Un osservatore in possesso di una formazione linguistica approfondita sarebbe invece immediatamente in grado di formulare domande e di introdurre distinzioni a un livello più sottile: quali categorie grammaticali creano difficoltà al paziente? Queste difficoltà si manifestano in contesti linguistici diversi? Sono correlate con altre difficoltà o distinzioni fonologiche, sintattiche, lessicali o pragmatiche?
Sussistono ancora molte difficoltà ad ottenere spiegazioni della funzione linguistica (per continuare con lo stesso esempio), che siano coerenti tanto sul piano psicologico che su quello linguistico, neuronale, antropologico e così via, in modo "che la nostra comprensione di un campo come il linguaggio possa riferirsi a tutte le prospettive scientifiche rilevanti, dal neurone alla nazione". Tuttavia, malgrado l'audacia dell'impresa,
il fine ultimo della scienza cognitiva dovrebbe essere - precisamente - quello di fornire una spiegazione scientifica convincente del modo in cui gli esseri umani conseguono i loro prodotti simbolici più notevoli: come perveniamo a comporre sinfonie, a scrivere poesie, a inventare macchine (compresi computer) o a costruire teorie (comprese teorie di scienze della cognizione). Una tale spiegazione dovrà incorporare i mezzi con cui gli esseri umani si imbarcano in progetti complessi per conseguire obiettivi ambiziosi; come rappresentano i loro piani; come cominciano a lavorare su un progetto, come organizzano le loro attività quotidiane (e non quotidiane!), come valutano abbozzi provvisori alla luce di informazioni e giudizi forniti da altre persone e in considerazione dei loro propri motivi e criteri, come determinano quando un tale programma o prodotto è stato completato, per iniziare poi una nuova linea di lavoro
Le argomentazioni che svolge Gardner nei brani appena citati chiariscono ulteriormente perché il Dipartimento di Psicologia decise di rivolgersi alla scienza cognitiva per rispondere in modo adeguato alla richiesta di esplicitazione, proveniente dal mondo della scuola, dei fondamenti cognitivi dei Nuovi Programmi. Nella pluralità dei punti di vista, nell'alto livello del dibattito, nella vivacità intellettuale che caratterizzano questo nuovo contesto di pensiero e di ricerca, sembrò opportuno collocare le risposte ad alcuni dei problemi educativi e didattici che la scuola elementare riformata pone ai suoi operatori.
La scienza della mente studia i modi in cui l'uomo si rappresenta le conoscenze, mentre la scuola opera affinché i giovani si rappresentino il mondo nei termini più adeguati ai loro bisogni personali e a quelli della società in cui vivono.
La scuola però non è in sintonia con le ricerche e con i dibattiti in corso presso le diverse comunità di scienziati cognitivi. Allo stesso modo la scieliza della mente svolge gran parte delle sue ricerche in contesti spesso artificiosi quali sono i suoi laboratori, e ben poco sa di quelle immense fabbriche della rappresentazione che sono le scuole.
Non sarebbe certo inutile che gli IRRSAE riflettessero seriamente se non sia loro dovere svolgere una funzione di "aggiustamento" tra le sedi della ricerca cognitiva (le comunità di scienziati della mente) e le sedi della praatica cognitiva (le scuole), attraverso operazioni culturali che abbiano il duplice effetto di mettere a disposizione delle scuole i risultati della ricerca sperimentale e a disposizione della ricerca sperimentale la concretezza e l'autenticità dei contesti di apprendimento che sono ritrovabili all'interno della scuola.
A proposito della nuova normativa che regola la scuola elementare italiana, vale la pena riprendere due argomenti che rendono particolarmente necessaria la familiarizzazione degli insegnanti con le ricerche, i dibattiti, i problemi della scienza della mente. Il primo argomento riguarda la rappresentazione delle conoscenze. Abbiamo già detto che si tratta del principale punto di convergenza tra tutti coloro che si definiscono scienziati della mente. Anche i Nuovi Programmi pongono questa tematica al centro degli obiettivi formativi che devono essere raggiunti dalla scuola elementare, quando affermano che il suo "compito specifico" è l'"alfabetizzazione culturale partendo dall'orizzonte di esperienze e di interessi del fanciullo per renderlo consapevole del suo rapporto con un sempre più vasto tessuto di relazioni e di scambi".
Tradotto nel linguaggio della scienza della mente, il brano citato significa che a scuola, innanzitutto e soprattutto, si deve lavorare sulle rappresentazioni delle conoscenze (o idee del mondo) che ciascun bambino si è costruito (e continua a costruirsi) durante le sue esperienze di vita, e contemporaneamente si deve lavorare sulle idee che la cultura consolidata ha elaborato nel corso dei secoli, al fine di trovare un'integrazione tra i due livelli di rappresentazione. Non sarebbe accettabile, dicono implicitamente i Nuovi Programmi, né un insegnamento-apprendimento che fosse fondato esclusivamente sui contenuti culturali consolidati (nozionismo), né un insegnamento-apprendimento che si fermasse alle idee spontanee dei bambini (attivismo ingenuo). La centralità intellettuale indicata dai programmi, che non va a scapito certo delle altre dimensioni di vita del bambino ma ne costituisce il punto di coagulo, si può realizzare soltanto attraverso un lento, costante, ricorsivo aggiustamento tra gli input provenienti dal mondo, le idee "spontanee" dei bambini, le idee consolidate della cultura.
E’ evidente che se questo è vero, una delle principali competenze dell'insegnante dovrebbe riguardare proprio i modi della rappresentazione e del cambiamento delle idee sul mondo.
Abbiamo visto che la rappresentazione ha le sue modalità di funzionamento che ci vengono indicate soprattutto dalla ricerca psicologica; ha i suoi modi di fondarsi sul piano neurologico che vengono indagati dalla biopsicologia; ha i suoi intrecci profondi con i canali comunicativi che ci vengono evidenziati dalla linguistica; ha le sue contestualizzazioni culturali che ci vengono segnalate dall'antropologia; ha le sue significazioni interpersonali che ci vengono esplicitate dalla psicologia sociale. La scienza cognitiva, che contiene in sé e cerca di integrare tutte queste diverse prospettive, ci pare davvero debba diventare una delle principali fonti di formazione per gli insegnanti.
Il secondo argomento da esplicitare riguarda il rapporto che esiste tra i Nuovi Programmi della scuola elementare e il vivace dibattito in corso tra modularisti e connessionisti.
I programmi compiono un'evidente scelta disciplinare. Infatti, a parte la premessa, l'intero testo programmatico è articolato per discipline. Contrariamente a quanto contenuto nei precedenti programmi, è stato abbandonato ogni generico globalismo e la modulazione disciplinare è prevista fin dal primo giorno di scuola. Ciò significa che i Nuovi Programmi non vedono nell'articolazione per discipline dell 'insegnamento~apprendiment0 un rischio per l'integrità personale del bambino, ma al contrario vi individuano la forma più produttiva di adeguamento della formazione scolastica alla naturale esperienza cognitiva del bambino stesso.
Siamo convinti che i motivi per i quali i programmi hanno compiuto questa scelta di fondo non siano stati esplicitati in modo adeguato agli insegnanti. Anche in questo caso la scienza della mente può fornire un valido supporto.
In particolare, le teorie modulariste hanno evidenziato come non esista una modalità di rappresentazione delle conoscenze che " vada bene su tutto"; lo comprova il fatto che la cultura contemporanea è fortemente differenziata al propno interno non soltanto per oggetti di studio (numeri, parole, fenomeni naturali, eventi storici, comportamenti sociali, suoni, immagini, gesti ecc.) ma anche e soprattutto per stili cognitivi. Guardare e spiegare il mondo dal punto di vista linguistico o dal punto di vista biologico o dal punto di vista matematico, richiede punti di osservazione, sensibilità, contesti di significato, criteri valutativi completamente diversi.
I modularisti più spinti, come Howard Gardner (1983), arrivano a dire che in realtà esistono "intelligenze" diverse e che in ogni soggetto un’intelligenza prevale su tutte le altre. E questo il motivo che spiega, secondo loro, perché la cultura consolidata si sia articolata proprio nel modo che conosciamo e non in un altro. Anche i modularisti più soft ritengono tuttavia che ci siano qualità diverse di rappresentazione del mondo e che questo dato di fatto vada posto al centro di quell'alfabetizzazione culturale che i programmi dicono essere il "compito specifico" della scuola elementare.
Ci pare che l'opzione fortemente disciplinarista operata sia dai programmi sia dalla riforma degli ordinamenti, la quale addirittura moltiplica per tre o più le figure dei docenti per ogni classe, sia stata fortemente influenzata dalle teorie modulariste. Il modello di scuola che ne deriva più che ricordare l'immagine di una rete dove tutto è collegato e connesso, tipica di una impostazione globalistica, potrebbe essere rappresentato con la metafora di un " viaggio " che il bambino compie tra i diversi contesti cognitivi (la lingua, la matematica, le scienze ecc.), allo scopo di "assaggiarne" gli aspetti peculiari e di imparare a "spiazzarsi" senza traumi da un punto di vista all'altro.
I Nuovi Programmi non ignorano, ovviamente, le suggestioni provenienti dagli ambienti connessionisti, i quali come abbiamo visto, anche grazie a simulazioni su calcolatori di nuovo tipo, sono sempre più impegnati a dimostrare l'interconnessione profonda che sussiste nella mente umana e che viene ampiamente comprovata dalle scoperte dei neuroscienziati ad approccio molare. Con frequenti richiami, i programmi sottolineano la necessità che gli alunni colgano non solo le differenze ma anche i punti di contatto tra le discipline e soprattutto, ci pare di capire, si rendano conto del senso profondo e unitario del " viaggio " di cui abbiamo detto. In altre parole è necessario che anche il bambino della scuola elementare conquisti la consapevolezza che il mondo in cui viviamo è un sistema complesso e integrato, che nulla sa delle nostre articolazioni disciplinari; e contemporaneamente acquisisca la padronanza dei modi specifici di rappresentarsi il mondo che vengono utilizzati dalla nostra cultura. Questo duplice obiettivo non lo si raggiunge però pasticciando in modo maldestro con presunte interdisciplinarità di superficie, come capita di leggere in certe riviste didattiche. Lo si deve perseguire invece, come dicono gli stessi programmi, mediante adeguate forme di metacognizione finalizzate all'"imparare ad imparare". Con questo termine va intesa la capacità del soggetto non soltanto di rappresentarsi il mondo ma anche di farsi delle idee su come egli stesso si rappresenta il mondo.
Quello della metacognizione è uno dei più recenti oggetti di studio della scienza della mente. Sempre più si fa avanti la convinzione che non può avvenire rappresentazione delle conoscenze senza che il soggetto sia in grado di autoregolare il suo proprio modo di pensare il mondo, attraverso riflessioni a carattere metacognitivo. Sarà pertanto opportuno che la sensibilità dimostrata dall'IRRSAE e dal Dipartimento di Psicologia nell'aver dato vita all'operazione culturale che è stata documentata in questo libro non decada in futuro e ci permetta di approfondire la conoscenza degli studi sulla metacognizione, in quanto ci pare che si tratti di un argomento cruciale per dare senso e completezza alla decodificazione in chiave cognitivista dei Nuovi Programmi, e per aiutare gli insegnanti a conciliare l'opzione disciplinare compiuta dalla recente normativa con la necessaria prospettiva unitaria che deve assumere ogni progetto formativo.
Dal punto di vista degli insegnanti che operano nello stesso "modulo", ci pare che il principale lavoro da compiere collegialmente non sia tanto quello di definire nei particolari il curricolo che ciascuno di loro dovrà svolgere all'interno dei contesti cognitivi di competenza, quanto quello di studiare e di discutere le tematiche contenute nel presente volume e altre di ancora maggiore tendenza, quali quelle che abbiamo appena ricordato in riferimento alla metacognizione. Il loro compito cooperativo sarà certamente quello di organizzare in modo adeguato il "viaggio" tra le discipline, ma anche e soprattutto quello di controllarne l'andamento complessivo e di riformularne il significato in sintonia con lo sviluppo di quelle vicende culturali che maggiormente sono in grado di fornire quadri di riferimento adeguati e spiegazioni utilizzabili.
(*) il saggio fa parte di un volume collettivo dal titolo "Scienza cognitiva ed educazione" pubblicato nel 1992 da Bollati Boringhieri per conto dell'Irssae Piemonte